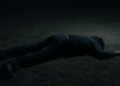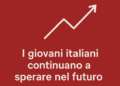Ci sono momenti nella storia in cui i valori della civile convivenza arrivano ad un passo dall’implodere, palesemente sfregiati dalle degenerazioni ideologiche portate all’estremizzazione di soluzioni rimesse all’uso della forza e delle armi attraverso espressioni inequivocabilmente arroganti nella parola e nella mimica oltre che nelle azioni di negazione della democrazia. In tali momenti tristemente epocali e drammaticamente ricorrenti viene da chiedersi, e senza retorica, se l’umanità abbia effettivamente compiuto un cammino evolutivo culturale oppure se reca in sé una irreparabile, fatale, regressione nel paleolitico inferiore.
Il 27 gennaio si ricorda l’Olocausto degli oltre 250 mila rom, dei 250 mila disabili ricoverati negli istituti, di Migliaia di omosessuali, di 6 milioni di ebrei, 7milioni di civili russi, 3 milioni di prigionieri di guerra russi, 1,8 milioni di civili polacchi, 312 mila civili serbi, 1900 testimoni di Geova, 70 mila carcerati a vario titolo.
Un numero indeterminato e impressionante di oppositori politici tedeschi e di altre nazionalità.
Oltre a questi numeri impressionanti si aggiungano gli oltre 700 mila deportati militari italiani, oltre 100mila deportati civili italiani.
Cosa ne sanno i nostri adolescenti?
In Olanda, il 59% della Gen Z non sa che nella Shoah furono assassinati sei milioni di ebrei, il 22% ritiene accettabile che un individuo sostenga le opinioni neonaziste e il 13% non ne è sicuro. L’89% conosce Anne Frank, ma il 32% non sa che morì in un campo di concentramento. Il 45% degli ebrei francesi preferisce che i loro figli non rivelino in pubblico che sono ebrei e il 20% è stato vittima di un’aggressione fisica antisemita. Tra i giovani canadesi e statunitensi dell’Ontario, circa un terzo ritiene che la Shoah sia «esagerata o inventata».
Adolescenza e memoria ci paiono stereotipi inconciliabili. D’altro canto, se si accusano gli adolescenti di bassa conoscenza dello sterminio e di scarso interesse, è vero anche che difficilmente è chiesta loro una collaborazione e corresponsabilità concreta, effettiva. Ma un punto di contatto è forse possibile: nella memoria l’adolescenza può trovare un po’ di senso, e nei giovani la memoria dello sterminio si può riscoprire lontana dall’essere un ricordo statico.
Nelle scuole, fare memoria richiede però una preparazione specifica e, ancor più oggi, una particolare sensibilità educativa: è necessario tenere a mente domande all’apparenza semplici (chi sono i giovani? Chi sono gli ebrei? Cos’è la memoria?), che chiamano però in causa risposte difficilissime e in continuo mutamento. Trovarne di via via più precise, creare un approccio positivo nel quale gli adolescenti sono partecipi e non semplici fruitori, è funzionale non solo all’acquisizione di contenuti ma a una consapevolezza più forte di quanto accadde, ed è ciò che insegnanti ed educatori sono chiamati a fare.
Per tutto questo, è necessario un impegno maggiore da parte di tutti. Ho letto con interesse con Noi siamo memoria di Matteo Corradini(*): una guida per insegnanti, educatori, genitori e chiunque desideri dare un senso alla memoria in un percorso sul perché, sui modi, sui tempi e sul senso, oggi, di una didattica della memoria. Affinché sia ancora possibile trasformarla in occasione importante di crescita umana e di responsabilità civile.

Tra riflessioni, studio della realtà concreta, attività da svolgere e una ricchissima bibliografia, l’autore avvicina a una tematica complessa senza smarrire la leggerezza educativa e la voglia di libertà e sperimentazione.
*Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Prepara reading musicali, regie teatrali, progetti di didattica della memoria. Premio Andersen 2018 e 2024, è tra i curatori del festival scrittorincittà (Cuneo). Dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali, ed è tra i fondatori dell’Institut terezínských skladatelů (Terezín Composers Institute) a Praga. Ha curato la nuova edizione del Diario di Anne Frank (Rizzoli), e le memorie di Virginia Gattegno (Per chi splende questo lume, Rizzoli). I suoi libri sono tradotti da Random House in Germania e da Gallimard in Francia. Con Erickson ha pubblicato Tu sei memoria. Percorsi su ebraismo e Shoah alla scuola primaria.