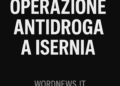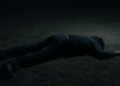Siamo nel pieno del triduo pasquale, i riti con i quali si celebra la Pasqua collettivamente. Riti cristiani ma che rappresentano ormai momenti anche della vita civile della nostra laica società. Per la cultura e le tradizioni e i riferimenti sociali e civili che attraversano queste ore. I riti pasquali iniziano il giovedì santo con la Messa in Cena Domini, a ricordo dell’ultima Cena di Cristo prima della Crocifissione.
In questi giorni, e ancor più nelle prossime ore, saremo ripieni di buoni sentimenti, di retorica da paroloni come solidarietà, amore, bontà, si celebra sempre più Colui che per Amore sfidò l’Impero del suo tempo, il Potere imperiale e la sua oppressione, sacrificando la sua vita per colpe non sue. La massima espressione di solidarietà e amore verso il prossimo. Quell’amore che non dovrebbe conoscere confini e paletti, che vede il primato della coscienza anche su leggi che si ritengono ingiuste e contrarie a quel che dovrebbe essere il comandamento supremo per i cristiani e per tutti coloro che celebrano la Pasqua.
Dovrebbe ma non sempre è così. Il primato della coscienza sicuramente guidò Egidio Tiraborrelli. Una storia che parte dall’Abruzzo, anzi per essere precisi dal vastese, ma che non ha mai avuto (nonostante tentativi sulla stampa locale di raccontarla) nessuna eco, nessun interesse, nulla di nulla. La raccontò Annamaria Rivera su Il Manifesto nel gennaio di cinque anni fa.
Nato a Casalbordino nel 1937 Egidio Tiraborrelli in tenera età «rimase gravemente ferito al capo a causa dell’esplosione di una mina ch’era destinata a distruggere un carro armato tedesco». A 16 anni con la famiglia emigrò in Argentina per, dopo decenni in giro per il mondo, rientrare in Italia a Parma solo ormai anziano e malato. Reduce da un’operazione e malato di tumore ai polmoni e costretto a vivere nell’indigenza. Nel 2017 fu condannato, sentenza passata in giudicato, perché in traghetto dalla Grecia all’Italia avrebbe aiutato una persona non in regola con i documenti poi espulsa dal BelPaese.
«Egidio, pur essendo in età tanto avanzata e in uno stato di salute sempre più grave, resterà in prigione per quasi nove mesi, in condizioni alquanto difficili: per dirne una, il carcere di Parma era dotato di un unico respiratore a ossigeno, che i detenuti infermi erano costretti a usare a turno – scrisse Annamaria Rivera su Il Manifesto – oltre tutto, tra le conseguenze della condanna v’era la sospensione della pensione e l’obbligo della restituzione di quel che aveva percepito. Infine, la sua avvocata riuscirà a ottenere per lui la detenzione domiciliare, ma solo nella forma di ricoveri temporanei, quando necessari, nella struttura sanitaria del carcere. Nel corso di uno di questi, Egidio si aggrava: muore il 6 settembre 2019».
«Sembra una narrazione letteraria dall’esito tragico la vicenda di cui scrivo: riferita a suo tempo dalla Rete Diritti in Casa, un collettivo di Parma che si batte per il diritto all’alloggio, nonché da alcune testate online di sinistra, poi raccolta e rilanciata dall’agenzia Agi e dal quotidiano Avvenire; non già da altri media di rilievo nazionale» scrisse Annamaria Rivera nell’incipit del suo articolo su Il Manifesto.
«La sua vicenda illustra in modo tragicamente esemplare almeno tre questioni importanti e assai attuali. Anzitutto il fatto che – come dicevamo un tempo – la giustizia sia tuttora giustizia di classe, tendente a mostrare il suo volto più severo, se non feroce, verso i più poveri e/o vulnerabili.
In secondo luogo, sembra predominare una concezione della pena carceraria quale crudele punizione, tale da poter essere inflitta anche a persone anziane, perfino gravemente malate; e ciò in palese violazione della Convenzione europea dei diritti umani, della nostra Costituzione, della stessa legislazione italiana. L’art. 47 ter della legge sull’ordinamento penitenziario prevede, infatti, la detenzione domiciliare per chi, condannato a una pena carceraria, abbia compiuto settant’anni o sia in condizioni di salute particolarmente gravi – denunciò l’antropologa sul quotidiano – Infine, al centro di questa storia angosciosa è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che, come si è detto, essendo considerato ostativo, non contempla misure alternative alla detenzione, salvo che il condannato soffra di gravi problemi di salute».
«Grazie all’esistenza di un tale reato, perfino gli atti di solidarietà più ovvi e spontanei – come quelli dettati dal dovere morale di «dar da mangiare agli affamati» – spesso cadono sotto la scure della repressione» concluse Annamaria Rivera su Il Manifesto.