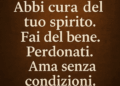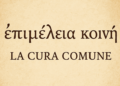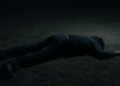In Sicilia, come in molte altre regioni d’Italia, la politica continua a mostrare il suo volto più opaco: quello dell’arroganza del potere, dell’impunità diffusa, della morale pubblica calpestata. Gli ultimi fatti di cronaca che coinvolgono il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, hanno riportato al centro del dibattito una questione fondamentale e mai risolta: la responsabilità etica della classe dirigente e le conseguenze sociali del cattivo esempio.
Galvagno, come riportano le inchieste della Guardia di Finanza, è indagato per peculato e corruzione nell’ambito di un’indagine più ampia che coinvolge una rete clientelare guidata dalla sua ex portavoce Sabrina De Capitani. L’utilizzo improprio dell’auto blu – formalmente restituita solo dopo l’apertura dell’indagine – è solo uno dei dettagli che raccontano un sistema dove il potere viene vissuto come privilegio personale, anziché come servizio pubblico.
Ma il caso Galvagno-Amata è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che si ripetono con inquietante regolarità. La Sicilia, da sempre terreno di intrecci tra politica, affari e criminalità organizzata, continua a essere laboratorio di un modello politico in cui l’etica è optional e l’idea di legalità si piega alla logica della convenienza.
Quando la classe politica si comporta come se fosse al di sopra della legge, l’effetto non è solo il discredito delle istituzioni. Il cattivo esempio, soprattutto se reiterato e impunito, si trasforma in un potente messaggio culturale: in Italia – sembra dirci la cronaca – chi ha potere può permettersi tutto. A questo si aggiunge una crescente percezione di ingiustizia: i reati dei “colletti bianchi”, spesso complessi da perseguire, vengono puniti con lentezza (se puniti), mentre quelli comuni sono trattati con fermezza. Il risultato è un cortocircuito nella coscienza collettiva.
Il legame tra politica corrotta e aumento della criminalità non è semplice da dimostrare con dati numerici, ma la letteratura criminologica e sociologica offre spunti chiari. Studi sul cosiddetto populismo penale indicano che, quando la politica appare indulgente con sé stessa e repressiva con i cittadini, la fiducia nella legge crolla. In parallelo cresce un senso di disobbedienza latente che legittima comportamenti illeciti come forma di “pareggio dei conti” con uno Stato percepito come ipocrita.
In Sicilia, il fenomeno si intreccia anche con l’eredità della criminalità organizzata. Secondo l’indice di presenza mafiosa, la regione resta tra le più esposte in Italia. La sovrapposizione tra reti clientelari, scambi di favori, nomine pilotate e gestione opaca di fondi pubblici non solo alimenta la sfiducia, ma crea anche spazi di manovra per mafie e imprenditori senza scrupoli.

Uno studio della Banca d’Italia ha già dimostrato come la presenza mafiosa rallenti lo sviluppo economico, danneggiando la competitività. Ma più sottile e grave è il danno culturale: in un contesto in cui i cittadini vedono ogni giorno politici impuniti, l’idea di rispettare le regole perde senso. La spavalderia diventa modello. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: evasione fiscale diffusa, abusivismo edilizio tollerato, favoritismi e concorsi truccati vissuti come normali.
In una società che osserva il vertice infrangere le regole senza conseguenze, anche il cittadino comune si sente legittimato a fare altrettanto. L’illegalità diventa stile di vita, la trasgressione regola non scritta. E il crimine – piccolo o grande – non fa più paura, perché viene percepito come parte integrante del sistema.
Non si può chiedere rigore ai cittadini se chi governa predica bene e razzola male. Non si può parlare di legalità nei convegni istituzionali mentre si trafficano nomine, si pilotano bandi o si approfitta delle auto blu per uso personale. La questione morale, tanto invocata da Berlinguer negli anni ‘80, è oggi più attuale che mai. Ma sembra scomparsa dal lessico della politica, schiacciata tra calcoli elettorali e spartizioni di potere. Anche il mondo dell’informazione ha una responsabilità.
Troppo spesso gli scandali vengono trattati come “normalità”, banalizzati o confinati nel chiacchiericcio social. Occorre invece restituire peso politico e culturale alla denuncia dei comportamenti illeciti, non solo perché infrangono la legge, ma perché danneggiano la società nel suo insieme.
La questione morale non è un fatto astratto. È un fatto politico e culturale, che riguarda tutti noi. Il degrado etico della classe politica si traduce, giorno dopo giorno, in un degrado della convivenza civile. Non è solo una questione di ruberie o di favoritismi. È un lento avvelenamento del senso di giustizia, che lascia spazio alla legge del più furbo. La Sicilia, con la sua storia difficile e la sua energia ancora incompresa, merita una politica diversa.
Ma perché cambi qualcosa, serve rompere il ciclo della complicità silenziosa. Chiedere trasparenza. Pretendere integrità. Perché l’etica non è una bandiera da sventolare in campagna elettorale: è un dovere quotidiano verso la comunità.
immagini create con IA