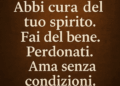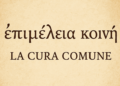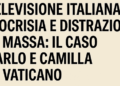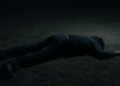Il “caso Kirk” ha fatto il giro del mondo. Non soltanto perché si tratta di un omicidio che ha colpito un volto noto della destra americana, ma soprattutto perché ha mostrato ancora una volta come la politica riesca a trasformare la tragedia in un’occasione di propaganda. In Italia, prima ancora di comprendere a fondo i fatti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono affrettati a inquadrarli dentro la solita cornice: l’odio della sinistra, l’attacco alla destra, la conferma di un clima che verrebbe sempre alimentato “dall’altra parte”.
Eppure, la realtà racconta altro. La stessa famiglia del ragazzo accusato dell’omicidio ha chiarito di non essere democratica, ma repubblicana, addirittura sostenitrice di Trump. Un dettaglio che sgretola la narrazione facile del “terrorista rosso” o del militante progressista assetato di sangue. Qui la sinistra non c’entra nulla, eppure si cerca di incastrarla dentro lo schema dell’odio politico, come se ogni evento drammatico dovesse per forza confermare una teoria già pronta.
Ma il punto non è solo questo. Il punto è l’uso che viene fatto della tragedia. Salvini, con una prontezza che lascia interdetti, ha annunciato la sua intenzione di andare nelle scuole a parlare con i ragazzi. Il messaggio sottinteso è chiaro: “lasciate che vi spieghi io cos’è la democrazia, cos’è l’odio, cos’è la politica”. Ma davvero è questo ciò di cui hanno bisogno gli studenti italiani? Davvero le aule scolastiche devono diventare il palcoscenico per l’ennesima messa in scena di un leader che ha fatto della propaganda la propria ragione di vita?
Di cosa dovrebbe parlare Salvini ai ragazzi? Dei comizi di Charlie Kirk, costruiti su slogan identitari e visioni semplicistiche del mondo? Della sua stessa carriera politica, basata sulla contrapposizione permanente, sulla ricerca di un “nemico” — che sia il migrante, l’Europa, il sud del Paese o chiunque non rientri nello schema rassicurante del “noi contro loro”? Sarebbe questo il modello educativo da proporre a una generazione che già vive in una società attraversata da paure, precarietà e incertezze?
La scuola dovrebbe essere il luogo in cui si formano coscienze libere, capaci di ragionare, di criticare, di dubitare. È lo spazio in cui si impara a costruire un pensiero autonomo, non a ripetere slogan preconfezionati. Eppure, l’idea di Salvini sembra muoversi in direzione opposta: trasformare un’aula scolastica in una tribuna politica, sfruttare la vulnerabilità dei più giovani per ottenere un ritorno in termini di consenso. È allucinante pensare che la fragilità e la curiosità naturale dei ragazzi possano essere piegate a un calcolo elettorale.
La destra di governo, Meloni e Salvini in testa, non sta facendo altro che ninalzare il livello dell’odio e polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico. Ogni evento diventa un pretesto per rafforzare l’identità del proprio elettorato, per convincere i già convinti, per alzare muri invece di costruire ponti. Ma in questo caso il rischio è ancora più grave: l’idea di entrare nelle scuole per portare non un’educazione civica, ma una lezione di propaganda.
E allora la domanda è inevitabile: chi educa chi? Può davvero un politico che ha costruito la sua carriera alimentando paure e divisioni presentarsi come l’insegnante di valori democratici? O non sarebbe piuttosto un cortocircuito, un inganno pericoloso?
Se davvero si volesse portare la politica nelle scuole, lo si dovrebbe fare in tutt’altro modo: attraverso il confronto, il pluralismo, la presenza di più voci, anche discordanti. Ai ragazzi andrebbe insegnato che la democrazia è complessità, non semplificazione; che il dissenso è legittimo, ma non deve mai trasformarsi in odio; che il dialogo è sempre più utile del nemico immaginario. Questo significa educare, non portare dentro le aule scolastiche la stessa retorica che inquina i talk show e le piazze.
Il caso Kirk dovrebbe essere un monito, non un trampolino di lancio. Dovrebbe spingerci a riflettere su quanto sia fragile il confine tra politica e fanatismo, su quanto sia facile passare dalla parola alla violenza. E invece lo si trasforma in arma di propaganda, in occasione per riaffermare schemi e slogan già logori.
La democrazia non sopporta il vuoto. Laddove mancano risposte reali ai problemi, prende spazio il rumore, la retorica, l’odio. E chi cavalca quel vuoto ottiene consensi immediati, ma lascia macerie culturali dietro di sé. È questo che rischiamo se permettiamo che le scuole diventino l’ennesimo palcoscenico politico: perdere non solo la libertà di pensiero dei ragazzi, ma la possibilità stessa di costruire una cittadinanza consapevole.
Alla fine, la domanda rimane aperta: vogliamo una scuola che insegni a pensare o una scuola che insegni a obbedire? La risposta che daremo determinerà il futuro della nostra democrazia.