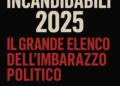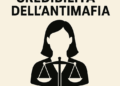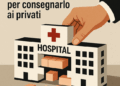Ci sono vicende che, più che un semplice fatto di cronaca, diventano uno specchio. Riflettono chi siamo come Paese, cosa intendiamo per giustizia, e quanto siamo disposti a rispettare i valori che dichiariamo di difendere. Il caso Almasri è una di queste.
Dietro il nome di Njeem Osama Almasri Habish, ex capo della polizia giudiziaria libica, si nasconde un intreccio complesso di politica, diritto e diplomazia. Ma soprattutto, si nasconde una domanda semplice e scomoda: l’Italia ha tradito i suoi impegni internazionali?
Tutto comincia a gennaio 2025, quando Almasri arriva in Italia. È accusato dalla Corte Penale Internazionale (CPI) di crimini di guerra e crimini contro l’umanità: torture, violenze, stupri. La polizia italiana lo arresta a Torino, ma nel giro di poche ore qualcosa cambia.
Invece di consegnarlo alla giustizia internazionale, l’Italia decide di rimandarlo in Libia con un volo di Stato, giustificando la scelta con “ragioni di sicurezza nazionale” e “rischio di ritorsioni”.
Il messaggio è chiaro: Roma ha preferito muoversi autonomamente, senza coordinarsi con la Corte. Un atto che, secondo la CPI, viola apertamente gli obblighi di cooperazione previsti dallo Statuto di Roma, trattato fondativo della Corte a cui l’Italia aderisce dal 2002.
La Corte non ha dubbi: l’Italia non ha rispettato i propri obblighi internazionali.
Lo ha messo nero su bianco in una decisione durissima, affermando che il nostro Paese non ha agito “con la dovuta diligenza” né utilizzato “tutti i mezzi ragionevoli” per eseguire il mandato di arresto o almeno per consultare la Corte prima di rimpatriare l’imputato.
Secondo la versione ufficiale, il governo italiano avrebbe agito per “motivi di sicurezza” e per evitare potenziali minacce. Ma la Corte Penale Internazionale non si è lasciata convincere.
Nessuna norma consente di ignorare un mandato di arresto per motivi politici. Nessun trattato lascia spazio a “eccezioni discrezionali”.
La verità, probabilmente, è che l’Italia ha scelto di proteggere i rapporti con la Libia, partner cruciale nei dossier energetici e soprattutto nel controllo dei flussi migratori. Una relazione fragile, fondata da anni su accordi e compromessi silenziosi, che spesso hanno un prezzo: quello dei diritti umani.
Il rimpatrio di Almasri non è stato solo un gesto diplomatico ma un segnale politico.
Un messaggio lanciato a Tripoli, ma che il mondo ha interpretato diversamente: un Paese europeo, membro della Corte Penale Internazionale, che decide di non rispettare un mandato internazionale.
Un gesto che indebolisce non solo la posizione italiana, ma l’intero sistema della giustizia internazionale, che vive della fiducia e della cooperazione degli Stati.
La decisione della CPI è chiara e pesante.
Roma – si legge nel documento ufficiale – non ha consultato la Corte, non ha chiesto chiarimenti, non ha cercato soluzioni. Ha semplicemente agito di propria iniziativa, rimandando Almasri in Libia.
Un’azione definita “incompatibile con gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma”.
Il punto centrale, secondo i giudici dell’Aia, non è solo la mancata consegna dell’imputato, ma l’assenza di cooperazione preventiva. In sostanza, l’Italia non ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
Una mancanza che mina la credibilità dell’intero sistema e che ora costringe il nostro Paese a rispondere.
La Corte ha concesso all’Italia tempo fino al 31 ottobre 2025 per fornire spiegazioni dettagliate sul perché non abbia rispettato gli obblighi e su come intenda garantire che episodi simili non si ripetano.
Se la risposta non sarà considerata soddisfacente, la CPI potrà deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati Parte o al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Una prospettiva che, al di là delle conseguenze legali, rappresenterebbe un disastro politico e d’immagine.
L’Italia rischia di essere bollata come uno Stato inaffidabile, pronto a sacrificare la giustizia internazionale sull’altare degli interessi geopolitici.
Una macchia profonda per un Paese che ama presentarsi come culla del diritto, patria della civiltà giuridica e promotore dei diritti umani nel mondo.
Sul piano pratico, questo potrebbe tradursi in: un calo di fiducia nei rapporti bilaterali e multilaterali, difficoltà nel negoziare o partecipare a missioni internazionali ed un indebolimento del ruolo italiano nelle istituzioni europee e nelle Nazioni Unite.
Ma il danno più grave è quello simbolico: aver messo in discussione l’impegno etico e morale dell’Italia nel rispetto del diritto internazionale.
La storia di Almasri non riguarda solo un generale libico, ma il concetto stesso di giustizia universale.
Quando la Corte Penale Internazionale emette un mandato, lo fa per garantire che anche i più potenti, anche chi si è macchiato dei crimini peggiori, rispondano delle proprie azioni.
L’Italia, firmando lo Statuto di Roma, ha scelto di sostenere questo principio.
Eppure, di fronte a un caso concreto, ha preferito il silenzio, la prudenza, la convenienza politica.
È la solita tensione tra sovranità e diritto internazionale, tra sicurezza nazionale e cooperazione globale.
Ma il vero problema è un altro: che messaggio dà un Paese democratico quando decide di non consegnare un sospetto di crimini contro l’umanità?
Che la giustizia vale solo finché non crea problemi? Che i trattati contano solo quando non toccano interessi sensibili?
In fondo, è questo che la Corte ci chiede di guardare in faccia: la contraddizione tra ciò che proclamiamo e ciò che facciamo.
Il caso Almasri è una ferita aperta per la credibilità internazionale dell’Italia ma anche un banco di prova per la nostra coscienza democratica.
Ci obbliga a riflettere su cosa significhi davvero appartenere a una comunità internazionale basata sul diritto e non sulla forza.
Perché un Paese che sceglie la scorciatoia politica al posto della giustizia, che antepone la diplomazia al rispetto dei trattati, finisce per indebolire non solo la propria parola, ma la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
La vera domanda, oggi, non è cosa accadrà ad Almasri, ma cosa accadrà all’Italia.
Se continuerà a essere vista come un Paese capace di onorare i propri impegni o se, al contrario, verrà ricordata per aver chiuso la porta alla giustizia internazionale in nome della convenienza.
E forse, nel silenzio che seguirà questa vicenda, l’Italia dovrà guardarsi allo specchio e chiedersi se davvero vuole essere ciò che dice di essere: una democrazia fondata sul diritto, o semplicemente uno Stato che sceglie quando il diritto conviene.