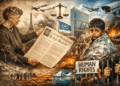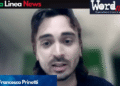Quello che sta accadendo a Minneapolis non riguarda solo l’America. Continuare a raccontarlo come un problema interno agli Stati Uniti è una scorciatoia comoda ma profondamente sbagliata. Perché ciò che vediamo oggi nel Minnesota parla un linguaggio che conosciamo bene anche qui, in Europa: quello dell’emergenza permanente, della sicurezza usata come giustificazione totale, della sospensione graduale delle domande scomode.
Le operazioni dell’ICE, il clima di tensione che si respira nei quartieri, la presenza federale vissuta come una minaccia e non come una tutela, non sono solo fatti di cronaca. Sono il segnale di una trasformazione più ampia: la paura che diventa metodo di governo.
E quando questo accade in una democrazia che si è sempre presentata come modello, il problema non può essere archiviato con un’alzata di spalle.
In teoria, tutto ciò che sta accadendo viene giustificato in nome della legalità. Controlli, arresti, operazioni speciali, tutto rientrerebbe nel perimetro delle competenze statali. Ma una democrazia non si misura solo dal rispetto formale delle regole. Si misura dal modo in cui quelle regole incidono sulla vita delle persone.
A Minneapolis, oggi, la legge non viene percepita come protezione. Viene percepita come minaccia. E quando questo accade, non importa quante volte si ripeta che “è tutto legittimo”, la frattura è già aperta.
La morte di Alex, infermiere di 37 anni, ha reso questa frattura impossibile da ignorare. Perché non si tratta più di un “bersaglio sbagliato” o di una tragica fatalità. Si tratta di una vita spezzata dentro un contesto che avrebbe dovuto garantire sicurezza, non produrre morte.
Ancora più grave è ciò che emerge attorno alle famiglie e ai minori. Al di là delle smentite ufficiali, il fatto che si discuta dell’uso dei bambini come possibile strumento operativo è già un fallimento politico e morale.
Una democrazia matura non dovrebbe nemmeno sfiorare certi scenari. Perché nel momento in cui la vulnerabilità diventa una leva, lo Stato smette di essere garante e si trasforma in dominatore.
Ed è proprio qui che la questione smette definitivamente di essere “americana”.
Il silenzio europeo è assordante. O peggio, è un silenzio interrotto da frasi che minimizzano, che normalizzano, che spostano l’asticella un po’ più in là. Quando si dice che “anche se fosse, non si vede il problema”, non si sta facendo una valutazione tecnica. Si sta facendo una scelta politica.
Perché ogni volta che un governo europeo mostra indulgenza verso pratiche che altrove generano paura, manda un messaggio preciso: il confine dei diritti è negoziabile.
E questo vale anche per l’Italia. Le parole pronunciate sul possibile coinvolgimento o sulla cooperazione con apparati come l’ICE, anche quando vengono presentate come ipotesi lontane o mal interpretate, rivelano un clima culturale preciso. Un clima in cui la sicurezza viene sempre prima, e tutto il resto viene dopo. Anche la libertà. Anche la dignità. Anche la storia.
Il paragone con apparati repressivi del passato non è propaganda. È memoria. Non si tratta di dire che siamo già arrivati lì ma di riconoscere i meccanismi che precedono sempre le derive autoritarie: il nemico interno, l’emergenza continua, la giustificazione di ogni mezzo, il disprezzo per chi solleva dubbi.
La storia europea dovrebbe renderci più attenti, non più indulgenti. E invece sembra accadere il contrario.
Il pericolo più grande non è l’operazione in sé. È l’abitudine. L’abitudine a vedere uomini armati nelle strade e pensare che sia normale. L’abitudine a sentire di morti “collaterali” e tirare dritto. L’abitudine a sacrificare qualcuno, sempre qualcun altro, in nome di una sicurezza astratta.
È così che la paura diventa sistema. Non con la violenza improvvisa ma con la rassegnazione quotidiana.
Il richiamo ad esperienze storiche come la Gestapo non va letto come un’accusa diretta ma come un avvertimento. Non si tratta di dire che siamo allo stesso punto ma di riconoscere dinamiche che la storia ha già mostrato: il nemico interno, la giustificazione totale dei mezzi, l’idea che la sicurezza autorizzi qualsiasi cosa.
Minneapolis oggi ci pone davanti a una scelta che riguarda tutti: restare spettatori o tornare cittadini. Perché la democrazia non si perde tutta insieme. Si perde quando smettiamo di reagire, quando accettiamo che certe cose “capitino”, quando ci convinciamo che non ci riguardano.
Il risveglio collettivo non è una parola retorica. È una necessità. Ribellarsi non significa violenza, ma rifiuto. Rifiuto della paura come strumento politico. Rifiuto dell’idea che la sicurezza valga più della vita. Rifiuto del silenzio complice.
Se oggi chiudiamo gli occhi su Minneapolis, domani non avremo più la forza morale di aprirli altrove. Perché la libertà non viene tolta: viene lasciata andare.
E quando ce ne accorgiamo, spesso, è già troppo tardi.
Immagine copertina AI