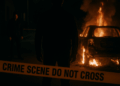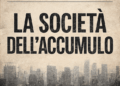Oggi, 23 agosto, ricordiamo la notte in cui l’America spense due vite sulla sedia elettrica e accese un simbolo che non si è più spento. Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, immigrati italiani, anarchici, operai, furono giustiziati nel penitenziario di Charlestown nel 1927 al termine di un processo che ancora oggi è una ferita aperta nella storia del diritto. È passato quasi un secolo, ma quel verdetto risuona come un monito: quando la paura guida il tribunale, la giustizia diventa un’ombra
La storia è nota e ostinata. Nel 1920, nel clima avvelenato del “Red Scare”, con perquisizioni arbitrarie, deportazioni e stampa scatenata contro i “sovversivi”, due italiani sono fermati con armi addosso e, dopo pochi giorni, trascinati nel gorgo dell’accusa più pesante: la rapina di South Braintree, due morti a terra, Frederick Parmenter e Alessandro Berardelli. Le prove? Indizi, perizie contraddittorie, riconoscimenti incerti, una cornice politica che vale più dei fatti. Il giudice Webster Thayer respinge richiesta dopo richiesta di nuovo processo, mentre fuori dalle aule cresce un’onda internazionale di protesta che unisce sindacati, scrittori, scienziati, vescovi, studenti. Quando nel 1925 un detenuto, Celestino Medeiros, confessa di aver partecipato a quella rapina con un’altra banda, la porta resta chiusa. Non è una questione di verità, è una questione di ordine: “dare un segnale”, mettere in riga gli anarchici, ammonire gli immigrati
Sacco è nato a Torremaggiore nel 1891, arriva in Massachusetts a diciassette anni, lavora nelle calzature, mette su famiglia. Vanzetti è del Cuneese, 1888, una costellazione di mestieri e la schiena dritta dei senza-paracadute: cava, acciaieria, trattoria, poi pescivendolo. Si incontrano nel 1916 tra compagni galleanisti, condividono idee, scioperi e l’esilio messicano per sottrarsi a una guerra non loro. In tribunale non sono due colpevoli, sono due figure su cui proiettare la nevrosi di un Paese: “radicali, stranieri, senza Dio”. Il resto viene da sé
Arriviamo a quella notte di agosto. Le ultime parole, la dignità, il rifiuto di mendicare la grazia. Vanzetti lascia un testamento morale che ancora punge: non chiede vendetta, chiede memoria. Sacco tiene il punto fino in fondo. Le esecuzioni si consumano in pochi minuti. Fuori, Boston trattiene il respiro; nel mondo, da Buenos Aires a Parigi, si accendono piazze, scritture, canzoni. Perché a volte due nomi diventano coscienza civile
La riabilitazione ufficiale arriva mezzo secolo dopo. Nell’agosto 1977 il governatore Michael Dukakis riconosce che Sacco e Vanzetti non ebbero un processo equo e chiede che ogni stigma sia rimosso dai loro nomi. Non è un atto magico che resuscita la giustizia mancata, ma è un documento che inchioda un’epoca alle sue responsabilità: pregiudizio politico, xenofobia, fobia del dissenso. Tre chiodi, una croce laica
Perché ricordarli oggi? Perché la storia non è un santino né un funerale infinito. È una bussola. Ogni volta che qualcuno propone “processi esemplari” o invoca “ordine” come clava, ogni volta che un’accusa regge solo su identità e idee di chi la subisce, ogni volta che il nemico pubblico di turno è un migrante, un attivista, un povero, la vicenda di Sacco e Vanzetti ci chiama all’appello. Il diritto vive di garanzie, non di fischi sugli spalti; di prove, non di paure; di giudici indipendenti, non di arbitri col fischietto del potere in tasca
Il futuro non si protegge con la nostalgia dell’errore, ma con la vigilanza. Facciamone una pratica quotidiana: pretendere trasparenza nelle perizie, severità nel vaglio delle prove, umiltà degli apparati, diritti che non cambino pelle a seconda del passaporto o delle opinioni. È questo il modo più serio di onorare due uomini che la storia ha fatto diventare idea
E allora, ogni 23 agosto, ripetiamolo senza sconti e senza retorica: non si tratta solo di Sacco e Vanzetti. Si tratta di noi, di come vogliamo essere giudicati quando il vento cambierà direzione. La memoria non è un lume votivo, è un faro. E illumina solo se lo teniamo acceso.