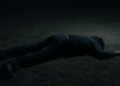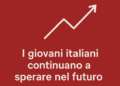Non è più politica, non è più confronto democratico. È un teatro in cui simboli, tragedie e paure vengono piegati a convenienza. Negli ultimi giorni abbiamo visto tre episodi che, presi singolarmente, potrebbero sembrare normali schermaglie di partito ma che letti insieme svelano un disegno più profondo e inquietante: Giorgia Meloni che alla festa di Gioventù Nazionale evoca Charlie Kirk come simbolo della lotta contro il pensiero unico; Roberto Vannacci che chiama i giovani a “essere gli eredi di Kirk”, trasformando una morte in bandiera da sventolare; Matteo Salvini che davanti alle telecamere di una tv israeliana proclama la sua amicizia indissolubile con Israele. Tre storie diverse, un unico filo: la costruzione di un immaginario politico che ha bisogno di martiri, di nemici e di un popolo disposto a credere che senza conflitto non ci sia identità.
Il nome di Charlie Kirk – giovane leader conservatore americano ucciso brutalmente – è stato rapidamente sequestrato dal dibattito politico italiano e trasformato in un simbolo. Non come monito contro la violenza, non come riflessione sul prezzo dell’intolleranza, ma come carburante per la propaganda. Il messaggio che passa è chiaro: chi si oppone al “pensiero dominante” rischia la vita, chi combatte contro il sistema è perseguitato, chi alza la voce diventa eroe. E allora, implicitamente, chi si schiera con Meloni, con Vannacci o con Salvini non sta semplicemente scegliendo un partito: sta abbracciando una crociata, sta indossando un’armatura.
Il problema è che quando una tragedia viene trasformata in mito politico, il confine tra memoria e manipolazione si dissolve. Si finisce per perdere la persona e restare con il simulacro: non Kirk in carne e ossa, con le sue contraddizioni e idee discutibili ma Kirk come feticcio da brandire. È un’operazione pericolosa perché sposta il discorso pubblico su un terreno emotivo, viscerale, in cui non contano più i fatti ma le suggestioni, non conta la politica come governo del reale ma come racconto epico.
Questa dinamica non è nuova. Negli anni di piombo, la radicalizzazione delle parole portò alle armi, i simboli si trasformarono in bersagli e la piazza diventò campo di battaglia. Oggi non siamo ancora lì ma ci stiamo muovendo lungo lo stesso crinale. Non c’è il piombo nelle strade, ma c’è la polvere da sparo nelle parole. Ogni discorso sembra fatto per polarizzare, ogni simbolo per dividere, ogni tragedia per essere usata come bandiera di guerra.
Il risultato è un fascismo 2.0, che non ha più il volto delle camicie nere ma quello delle dirette televisive e delle piazze virtuali. È un fascismo che si nutre di slogan, che delegittima il dissenso invece di ascoltarlo, che trasforma la paura in collante sociale. Non è un caso che Meloni insista sul “noi non abbiamo paura”: è la frase tipica di chi vuole trasformare la paura in arma politica, e nel farlo crea implicitamente un nemico da temere.
C’è chi liquida tutto questo come normale dialettica politica. Ma non è così. Non si tratta più di destra contro sinistra, di progressisti contro conservatori. Si tratta di capire se vogliamo restare dentro una democrazia o se siamo disposti a consegnarci ad una nuova stagione di odio. Quando un omicidio diventa propaganda, quando la morte di un uomo viene usata per consolidare il consenso, non siamo più dentro lo spazio del confronto democratico: siamo dentro un gioco pericoloso, in cui la realtà viene distorta per alimentare un clima di guerra culturale permanente.
E se da un lato Vannacci invoca “eredi di Kirk”, dall’altro Salvini rilancia il suo ruolo internazionale presentandosi come “amico di Israele”. Ma anche qui, più che un’idea di politica estera, c’è una strategia di immagine: posizionarsi come difensore, come alleato, come guerriero della civiltà. Non importa quanto queste parole abbiano peso reale nelle relazioni tra Stati: importa come suonano alle orecchie di chi ascolta, come rafforzano la percezione di un fronte compatto contro un nemico indefinito ma onnipresente.
Il contesto globale rende questa retorica ancora più pericolosa. Il Mediterraneo è una polveriera, l’Europa si sente accerchiata, l’America si lacera nelle sue divisioni interne, la Russia continua a spingere sull’instabilità. Siamo sull’orlo di un terzo conflitto mondiale ed invece di immaginare ponti e soluzioni diplomatiche, i nostri leader si concentrano sulla costruzione di muri identitari, su parole che incendiano invece di spegnere. È la logica del “noi contro loro”, la stessa che ha portato nel Novecento a catastrofi di proporzioni inimmaginabili.
La verità è che oggi ci sarebbe bisogno di un “Masaniello” ma non di uno destinato a essere tradito, manipolato ed ucciso dopo pochi giorni di rivolta. Ci sarebbe bisogno di una nuova presa della Bastiglia, non nel senso della violenza, ma nel senso di una rivoluzione morale e civile che rimetta al centro la dignità delle persone, il valore della verità, la responsabilità della politica. Ma questa rivoluzione non arriva perché il popolo è stanco, diviso, bombardato da messaggi che lo confondono e lo paralizzano.
Stiamo andando alla deriva e la deriva è subdola perché non la senti finché non è troppo tardi. Un giorno ti svegli e scopri che non hai più terra sotto i piedi, che il confronto non è più possibile, che la libertà di parola esiste solo se ripeti il coro giusto. L’Italia – e con essa l’Europa – si trova sospesa tra il desiderio di sicurezza e la tentazione dell’autoritarismo. Ma la storia ci insegna che quando la sicurezza diventa pretesto per chiudere le bocche, allora non è più sicurezza: è prigionia.
La domanda che dovremmo porci non è “chi sarà il prossimo erede di Kirk”, ma “quanto siamo disposti a sacrificare ancora sull’altare di un’identità che si nutre di nemici per sopravvivere”. La politica non può continuare a costruire consenso sull’odio, perché l’odio ha sempre una scadenza: oggi serve a vincere elezioni, domani a giustificare repressioni, dopodomani ad incendiare strade. E la storia, lo sappiamo, tende a ripetersi, ma non sempre con la possibilità di un lieto fine.
O la fermiamo adesso, o saremo noi a raccontare ai nostri figli, ai nostri nipoti, che non abbiamo visto arrivare il baratro mentre applaudivamo chi trasformava un morto in slogan e un popolo in gregge.
Immagine AI