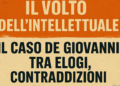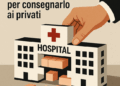Armando D’Alterio, già procuratore generale presso la Corte d’appello di Potenza . E’ stato premiato alla prima edizione del premio nazionale Pier Paolo Pasolini, per il suo romanzo inedito “Il ghiaccio dentro”. Quali sono le sensazioni e quanto è importante un evento come questo?
L’evento ha commemorato l’arte di Pasolini ed il suo messaggio di democrazia.
L’arte ed il messaggio si distaccano così dall’autore e diventano patrimonio comune, che si fissa vivido nella nostra memoria.
Sono onorato dal premio assegnatomi anche perché la protagonista del romanzo ha molto in comune con Lea Garofalo, del cui tentato sequestro mi sono occupato, con conseguente condanna definitiva di mandante ed esecutori.
Ha il suo coraggio di battersi per la legalità, pagando a caro prezzo per il suo impegno.
Lei infatti, tra le altre cose, si è occupato del caso di Lea Garofalo e di Giancarlo Siani e, grazie anche al suo lavoro, si è arrivati alla verità. Parlando di Lea, e quindi di testimoni di giustizia, qual è la situazione attuale sui testimoni di giustizia, cosa si ritrovano ad affrontare e cosa è cambiato nel corso del tempo?
La scelta di testimoniare nei delitti di criminalità organizzata, pur trovando sostegno da parte dello Stato (indennizzi, cambi di identità, spese di trasferimento, sostegno lavorativo) trova ancora la sua prioritaria compensazione nella consapevolezza di aver assolto ad un dovere civico, il cui adempimento contribuisce alla crescita, sociale -e tuttavia anche economica- del Paese.
Peggiore, paradossalmente, è la posizione delle parti lese del reato che non abbiano operato una scelta collaborativa. A causa di una recente riforma, pur quando sia accertata definitivamente la responsabilità degli autori del reato, le parti lese non potranno ottenere l’indennizzo di stato quando non siano del tutto estranee all’ambiente criminale, anche a causa di semplici rapporti di frequentazione, persino se riferiti a persone diverse dagli autori del reato.
E’ una scelta che penalizza la persona in virtù di circostanze prive di alcun rilievo, che come tali non consentirebbero nemmeno di attivare misure di prevenzione; si appone un ingiusto marchio criminale alla casualità della nascita in una determinata famiglia ovvero dell’abitazione in un particolare quartiere.
Andiamo a Giancarlo Siani, il 23 settembre è stato l’anniversario del suo omicidio. Quanto è ancora oggi importante la sua figura, che impatto ha avuto nel mondo del giornalismo e qual è la situazione attuale del giornalismo in Italia, grazie anche a delle riforme approvate che limitano la possibilità di farlo seriamente?
Penso che l’importanza della sua figura si spieghi anche perché lui non è stato soltanto un cronista dei fatti di mafia ma anche della incidenza sociale del fenomeno criminale sulle tematiche del lavoro, della disoccupazione, dello sviluppo e dell’ambiente. Questo gli ha consentito di evidenziare quanto l’incuria verso quelle tematiche abbia consentito la crescita delle organizzazioni criminali e della corruzione, che consente alle bande criminali di infiltrarsi nelle istituzioni diventando mafia e quindi principale causa della deriva socio-economica del Paese.
Siani era giunto ad acquisire i lineamenti della tangentopoli oplontina otto anni prima di quella nazionale. Indagando sul suo omicidio -e quindi sulla sua personalità, interessi ed azione nella misura in cui potessero trasformarlo in un obbiettivo- siamo giunti, oltre che alla condanna di mandanti ed esecutori del delitto, anche a quella dei pubblici amministratori che gestivano il malaffare politico-criminale, che costituì il retroterra dell’omicidio e su cui lui indagava e scriveva.
L’intenso impegno giornalistico conseguito al delitto ha poi creato nuove consapevolezze su di una realtà tanto pericolosa, quanto all’epoca ancora misconosciuta.
Per quanto riguarda l’attualità, è evidente che gli spazi di azione del giornalismo d’inchiesta si sono ridotti; il che non deve indurre ad arrendevolezza ma, al contrario, impone un salto di qualità che possa contrastare l’ indebolimento della sua azione.
La legge sulla presunzione di innocenza e, ancor prima, la normativa a tutela della riservatezza, dei dati sensibili e dell’immagine della persona, hanno aperto nuovi spazi a tutela della persona, che hanno allargato la capacità repressiva della diffamazione a mezzo stampa e della sua tutela civilistica. L’impossibilità di pubblicare stralci delle ordinanze di custodia cautelare ha reso persino più difficile quella branca, importante, del giornalismo d’inchiesta, basata sullo studio degli atti delle indagini e del processo penale. Sempre più si esige, si deve esigere, allora , dal giornalista, una qualificatissima professionalità, fatta di tanto lavoro, capacità di lettura, sintesi, valutazione e racconto degli atti del processo non coperti dal segreto. Resta peraltro, impregiudicato, il diritto-dovere del giornalista d’inchiesta di approfondire e divulgare i connotati e la gravità del fenomeno criminale in sé, segnalandone così i nuovi connotati, oltre che alla pubblica opinione, agli stessi inquirenti.
Diverse riforme della giustizia e inerenti al mondo della giustizia sono state approvate e altre sono in votazione (intercettazioni, abuso d’ufficio, traffico d’influenze, Corte dei Conti, separazione delle carriere). Ma è questo quello che serve alla magistratura anche per combattere le mafie?
Per questo servono più magistrati (in Germania, in rapporto alla popolazione, i magistrati sono il quadruplo che in Italia); serve aumentare le assunzioni nelle forze dell’ordine, da destinare esclusivamente a supporto delle procure della Repubblica. Servono norme che consentano l’effettiva entrata in funzione del processo telematico e l’accelerazione dei dibattimento che eviti la prescrizione dei reati. Serve soprattutto , dopo l’abolizione dell’abuso d’ufficio, il rafforzamento dei controlli amministrativi sulla legalità e trasparenza dell’azione amministrativa, ripristinando quantomeno i Comitati regionali di controllo, aboliti dalle regioni dopo l’abrogazione dell’art. 132 della Costituzione, che ne sanciva l’obbligatorietà e non indebolendo l’efficacia dell’azione della Corte dei Conti. Va espressa poi effettiva capacità di contrasto alle infiltrazioni criminali nei pubblici appalti, esaltando le potenzialità, tuttora deboli in sede attuativa, della legge del 2010, che prevedeva la tracciabilità bancaria dei finanziamenti erogati come corrispettivo degli appalti , tramite l’istituzione di conti correnti dedicati, ma non istituiva procedure e strumenti per verificare il rispetto degli obblighi di effettivo utilizzo successivo all’aggiudicazione dell’appalto.