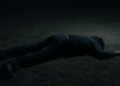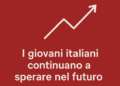Si ripropone con forza la questione dell’introduzione di telefoni cellulari nelle carceri italiane, un fenomeno tanto diffuso quanto inquietante, che mina le fondamenta della sicurezza penitenziaria e alimenta il potere criminale anche dietro le sbarre.
L’ultima inchiesta giudiziaria porta di nuovo in primo piano il nome del clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia, una delle organizzazioni camorristiche più radicate e influenti del territorio campano.
A finire sotto la lente degli investigatori è Miriam Teresa D’Alessandro, 23 anni, figlia del boss Luigi D’Alessandro, detenuto in regime di 41-bis. La giovane è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver introdotto un cellulare all’interno del carcere di Larino (Molise), destinato al marito Francesco Paolo Savarese, anch’egli detenuto, grazie alla complicità di un agente di polizia penitenziaria.
I tre sono stati rinviati a giudizio con rito immediato, segno della gravità dei fatti e della solidità delle prove raccolte dagli inquirenti.
La complicità dell’agente penitenziario, emersa come elemento chiave dell’indagine, conferma una prassi consolidata in diversi istituti di pena italiani: i cellulari in carcere diventano strumenti di potere e controllo, mezzi con cui i boss mantengono il contatto con l’esterno, impartiscono ordini, gestiscono affari e perfino realizzano dirette social.
Un cortocircuito istituzionale che mina il principio stesso della pena detentiva, trasformando la cella in un’estensione del quartier generale criminale.
Ma il carcere di Larino non è nuovo a simili ombre.
Già in passato, una famiglia legata al clan D’Alessandro, i Vuolo, era riuscita ad aggiudicarsi un appalto pubblico per la fornitura di barriere fonoassorbenti proprio all’interno dell’istituto molisano.
A fermare quell’operazione fu Gennaro Ciliberto, testimone di giustizia che denunciò pubblicamente la presenza della camorra negli appalti autostradali e segnalò gravi anomalie costruttive nelle opere realizzate dalla ditta riconducibile ai Vuolo.
Le sue rivelazioni provocarono un terremoto giudiziario e mediatico: come potevano dei soggetti già condannati per reati di mafia, interdetti dalla Prefettura di Napoli e sotto inchiesta da diverse DDA, ottenere un appalto pubblico in un carcere italiano?
La storia si ripete, e con essa il sospetto di una rete di connivenze e omissioni che attraversa istituzioni, amministrazioni e imprese pubbliche.
Chi ha permesso che per decenni i Vuolo e i D’Alessandro continuassero a operare indisturbati nei gangli dello Stato?
Chi ha chiuso gli occhi davanti alle interdittive antimafia e ai segnali evidenti di infiltrazione?
Il caso di Larino non è solo un episodio isolato: è il simbolo di un sistema permeabile, dove il potere criminale entra, si insinua e sopravvive, anche dietro le sbarre, anche nei luoghi che dovrebbero rappresentare la legge.
Immagine AI