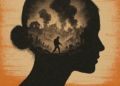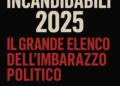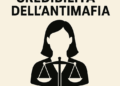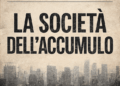C’è qualcosa di simbolico — e insieme inquietante — nel vedere un governo finire sotto accusa per genocidio mentre, nello stesso tempo, uno dei suoi ministri promette di “fermare l’onda rossa”.
Da un lato, una denuncia internazionale che punta il dito contro il potere. Dall’altro, il potere che alza i muri per contenere chi lo contesta. In mezzo, un Paese che sembra sempre più stretto tra le sue paure e le sue contraddizioni.
La notizia è di quelle che, anche se non portano conseguenze immediate, lasciano un segno: Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Guido Crosetto e l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, sono stati denunciati alla Corte penale internazionale per concorso in genocidio.
Parole pesantissime, che colpiscono come un macigno.
La denuncia, partita da un gruppo di giuristi e attivisti per la Palestina, accusa il governo italiano di aver avuto un ruolo — diretto o indiretto — nel sostenere, con contratti e forniture, l’azione militare israeliana su Gaza.
Non si parla solo di politica estera, ma di responsabilità morale e materiale: di aver mantenuto accordi, licenze, rapporti industriali con chi, oggi, è accusato di crimini di guerra.
Naturalmente, nessuno dei denunciati rischia, almeno per ora, un mandato d’arresto o un processo. La Corte penale internazionale riceve spesso segnalazioni di questo tipo, e il procuratore dovrà decidere se aprire o meno un’inchiesta. Ma il punto non è tanto giudiziario quanto politico e simbolico.
Per la prima volta, i vertici di un Paese dell’Unione Europea vengono accusati, nero su bianco, di aver “contribuito” a un genocidio in corso. È un atto di accusa contro un intero modo di intendere la politica estera: quella che, dietro le parole sulla pace, continua a stringere mani, firmare contratti, garantire forniture.
E se da Palazzo Chigi si parla di “denuncia infondata”, “offensiva”, “unica nel suo genere”, il dato di fondo resta: l’Italia, oggi, non appare neutrale.
È dentro una rete di alleanze, interessi e scelte che la rendono parte di un sistema di potere, non di mediazione.
E quando un Paese che si definisce “difensore dei diritti umani” viene accusato di complicità in crimini contro l’umanità, qualcosa si incrina nel suo stesso racconto di sé.
Che cosa rischiano, dunque, Meloni, Tajani, Crosetto e Cingolani?
Forse nulla di immediato sul piano legale, ma molto sul piano della credibilità.
Perché la politica, oggi più che mai, vive di immagini, di reputazione, di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa.
E un governo che si presenta come difensore dei valori occidentali e della libertà, ma viene denunciato per genocidio, porta su di sé un marchio che non si cancella facilmente.
Leonardo, poi, è un simbolo perfetto di questa ambiguità. È l’orgoglio industriale nazionale, l’azienda che rappresenta l’eccellenza tecnologica italiana nel mondo. Ma è anche il cuore dell’industria militare. E quando le bombe cadono, chi le produce non può nascondersi dietro la parola “difesa”.
Perché ogni vite spezzata, ogni edificio distrutto, ogni bambino ferito porta con sé un pezzo di quella filiera.
E se il confine tra chi “produce sicurezza” e chi “fornisce strumenti di guerra” diventa labile, la domanda che resta sospesa è semplice: fino a dove può spingersi la complicità?
Meloni risponde con fermezza: “L’Italia non ha autorizzato nuove forniture di armi a Israele dopo il 7 ottobre”.
Ma la verità è che, anche senza nuovi contratti, la macchina bellica non si ferma. Le manutenzioni, i supporti tecnici, le licenze già in corso continuano. E in un conflitto come quello in corso, basta anche un bullone per sentirsi parte di ciò che accade.
Non è questione di diritto, è questione di coscienza.
Ed è curioso che proprio nei giorni in cui il governo viene accusato di crimini internazionali, il vicepremier Matteo Salvini invochi una crociata interna per “fermare l’onda rossa”.
L’espressione ha il tono della propaganda, ma anche dell’allarme.
Un’onda rossa che, nelle sue parole, sarebbe composta da studenti, sindacati, associazioni, movimenti pro-Palestina, e più in generale da un pezzo di Paese che non accetta le politiche di questo governo.
Salvini parla di “odio”, di “disordine”, di “pericolo per la sicurezza”. Propone leggi più severe per chi manifesta, cauzioni preventive, restrizioni.
Ma la verità è che la sua “onda rossa” non è altro che la coscienza civile di chi ancora si indigna.
C’è una certa ironia in tutto questo: mentre l’Italia viene trascinata davanti alla Corte dell’Aia, il governo vuole trascinare in tribunale i propri cittadini.
Chi denuncia i crimini del potere diventa, agli occhi del potere, il vero pericolo.
Si crea così un cortocircuito pericoloso: chi manifesta per la pace viene trattato come un potenziale sovversivo; chi chiede verità e trasparenza viene zittito in nome della “sicurezza nazionale”.
E allora non è solo una questione di accuse o di leggi. È una questione di democrazia.
Perché una democrazia che non accetta il dissenso, che ha paura delle piazze, che risponde alle domande con manganelli o decreti, è già una democrazia malata.
E se chi governa si difende dal popolo invece che con il popolo, il rischio non è più il caos: è l’autoritarismo.
La denuncia per genocidio e la retorica sull’“onda rossa” sono, in fondo, due facce della stessa medaglia:
da una parte, il potere che viene messo sotto accusa; dall’altra, il potere che si blinda.
Entrambe le cose nascono da una paura profonda: la perdita di controllo.
Il governo Meloni teme che il racconto del “governo forte” si incrini. Teme che il peso morale della guerra lo schiacci, che le piazze italiane tornino a essere il luogo del dissenso e non del silenzio.
E allora reagisce chiudendosi a riccio, alzando il tono, polarizzando tutto.
Ogni protesta diventa “un attacco”, ogni denuncia “un complotto”, ogni richiesta di pace “un atto di odio”.
Ma la verità è che il potere, quando smette di ascoltare, smette anche di capire.
E un potere che non capisce più il proprio popolo è destinato, prima o poi, a scontrarsi con la realtà.
L’Italia, oggi, rischia di più di quanto sembri.
Non tanto un procedimento giudiziario, ma qualcosa di più profondo: la perdita di credibilità morale.
Perché non si può parlare di “diritti umani” e restare in silenzio davanti a migliaia di civili bombardati.
Non si può celebrare la “sovranità nazionale” e poi piegarsi a interessi esterni, economici o militari.
Non si può invocare la libertà, e al tempo stesso, limitare quella degli altri.
Ogni volta che una nave di aiuti umanitari viene fermata, ogni volta che una manifestazione viene caricata, ogni volta che un giornalista viene attaccato per aver criticato il governo, l’Italia perde un pezzo della sua democrazia.
E a quel punto non serve la Corte dell’Aia per dire che qualcosa non va: basta guardarsi allo specchio.
Se questa denuncia avrà o meno seguito giudiziario, lo decideranno i tribunali.
Ma ciò che è certo è che, in questo momento, il Paese è già sotto processo — nella coscienza dei suoi cittadini e nella memoria collettiva.
E un popolo che smette di farsi domande, che accetta tutto in nome dell’ordine, che chiama “pace” il silenzio e “stabilità” la paura, è un popolo che ha già rinunciato a scegliere.
La storia insegna che i processi più importanti non si tengono nei tribunali, ma nella memoria dei popoli.
E che spesso la verità arriva tardi, ma arriva.
Oggi, forse, l’Italia non rischia condanne. Ma rischia di trovarsi, domani, a dover spiegare ai propri figli perché ha preferito voltarsi dall’altra parte, perché ha scelto di reprimere le voci invece di ascoltarle, perché ha difeso la ragione di Stato invece del valore della vita.
E allora sì, forse il vero pericolo non è l’“onda rossa”.
È l’onda del silenzio.
Quella che, piano piano, cancella le coscienze, le domande, le responsabilità.
E lascia solo l’eco di un Paese che, per paura di ammettere la propria colpa, ha smesso di avere una voce.