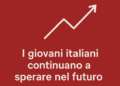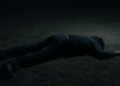Sono passati cinquant’anni dal massacro (sezna mandanti e senza esevutori materiali) di Pier Paolo Pasolini, eppure il suo sguardo continua a bruciare come brace viva sotto la polvere del tempo.
Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, presso l’Idroscalo di Ostia, un corpo massacrato mise fine a una vita e diede inizio a un mistero che l’Italia non ha mai davvero voluto risolvere. Pier Paolo Pasolini, poeta, regista, scrittore, giornalista, intellettuale scomodo, moriva.
Ma nasceva il suo mito: quello di un uomo che aveva visto troppo e detto tutto, in un Paese che non voleva ascoltare.
Un profeta scomodo, un intellettuale totale
Pasolini è stato molte cose: poeta delle borgate, cineasta del sacro e del profano, analista feroce del potere, coscienza collettiva di un’Italia che stava vendendo l’anima al progresso. Aveva previsto tutto: l’omologazione culturale, la fine del popolo, la mutazione antropologica del Paese.
Lo chiamavano “corsaro”, e lui stesso si definiva “una forza del passato”. Ma quel passato era già futuro: la sua rabbia poetica, i suoi articoli, i suoi film e le sue profezie parlano oggi più di ieri.
Cinquant’anni dopo, l’Italia di Pier Paolo Pasolini è diventata l’Italia che lui temeva. Una società dei consumi dove tutto è merce, anche l’indignazione. Una nazione che ha perso la sua lingua contadina, la sua innocenza, la sua capacità di ribellarsi.
La morte e il mistero: l’Italia che non ha mai voluto sapere
L’omicidio di Pasolini resta una ferita aperta, una verità negata. Le sentenze dicono una cosa, la storia un’altra.
A cinquant’anni dalla notte dell’Idroscalo, restano domande che bruciano: chi aveva paura di Pasolini?
Chi temeva le sue parole, i suoi articoli, il suo libro incompiuto Petrolio, dove il potere si confondeva con la corruzione, la politica con il crimine, la Chiesa con la finanza?
Non si è mai trattato solo di un delitto. È stato un omicidio politico-culturale, l’eliminazione simbolica dell’unico intellettuale che osava dire che “il vero fascismo è la società dei consumi”.
Il pensiero che non muore: l’eredità culturale di Pasolini
C’è qualcosa di profondamente vivo nel pensiero di Pier Paolo Pasolini. Lo si ritrova nei dibattiti, nei teatri, nei libri, nelle scuole (poco). Lo si ascolta nelle voci dei giovani che cercano un linguaggio diverso da quello del marketing e del potere. Ogni volta che qualcuno denuncia un’ingiustizia, ogni volta che la cultura prova a resistere alla volgarità dominante, Pasolini è lì.
La sua eredità culturale non è una reliquia, ma un seme.
Ha insegnato che la libertà è una pratica quotidiana, non un privilegio; che la verità non è mai comoda, e che la poesia può essere una forma di resistenza.
Il Pasolini che ci serve oggi
Nel 2025, tra crisi ambientali, guerre, propaganda e disinformazione, Pier Paolo Pasolini ci manca. Aveva capito che il potere non si combatte solo con le armi o le ideologie, ma con la coscienza, con la parola, con la verità.
Rileggere Pasolini significa tornare a sentire vergogna, indignazione, desiderio di giustizia. Significa riconoscere che la libertà non è mai data una volta per tutte.
A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, l’Italia ufficiale lo celebra: convegni, mostre, rassegne, commemorazioni. Ma lui, se fosse vivo, le avrebbe probabilmente disertate. Perché Pasolini non voleva essere celebrato: voleva essere ascoltato. E oggi, più che mai, abbiamo bisogno di ascoltarlo.
Non come un santo laico o un martire, ma come un uomo che aveva avuto il coraggio di restare umano.
“Siamo tutti in pericolo”.
Aveva ragione. Cinquant’anni dopo, viviamo immersi nel pericolo che lui aveva previsto, quello dell’indifferenza, del conformismo, della perdita della memoria. E allora ricordarlo non basta. Bisogna leggerlo, parlarne, insegnarlo, citarlo. Perché la sua voce non è un’eco del passato, ma la coscienza del presente.
E se davvero vogliamo rendere onore a Pier Paolo Pasolini, dobbiamo fare ciò che lui fece per tutta la vita: dire la verità, anche quando fa male.
Immagini AI