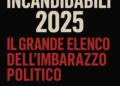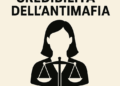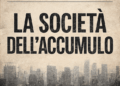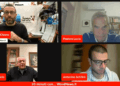C’è una cosa che negli ultimi mesi colpisce più di qualsiasi analisi geopolitica: la velocità con cui dimentichiamo. Bastano poche settimane, a volte pochi giorni, per vedere scivolare via dal dibattito pubblico tragedie che fino a poco tempo fa riempivano le piazze, i giornali, i nostri discorsi. È come se la sofferenza del mondo fosse diventata un sottofondo costante, una musica che ormai non ascoltiamo più davvero. Ed è un paradosso tragico: più atroci sono le notizie, più in fretta diventano “troppo”.
Prendiamo Gaza. A gennaio, con l’annuncio del cosiddetto cessate il fuoco, sembrava che qualcosa stesse finalmente cambiando. Si è parlato di tregua, di ritorno degli ostaggi, di corridoi umanitari. L’Europa ha applaudito, il mondo ha tirato un mezzo sospiro. Per qualche giorno se ne è discusso ovunque: talk show, giornali, social, striscioni nelle manifestazioni. Tutti a chiedersi se quella fosse davvero la prima pietra per una pace possibile.
Poi, lentamente, un silenzio. Un silenzio che non è pace, ma rimozione.
Perché la verità – quella meno comoda – è che quel trattato ha acceso i riflettori solo per un istante. La vita a Gaza continua a essere segnata da condizioni disumane: le città sono macerie, gli sfollati vivono senza garanzie e gli aiuti entrano col contagocce. Ma questo, di colpo, non sembra più attirare clic, visualizzazioni, dibattiti politici. Lo scroll è andato avanti. Un nuovo tema, un nuovo allarme, una nuova emergenza.
Eppure basterebbe tornare a leggere le testimonianze degli esperti per capire che non esiste alcun “dopo” reale per chi vive laggiù. La tregua non ha asciugato il sangue, non ha restituito le case, non ha fermato le tensioni politiche. È una pausa fragile, quasi simbolica, che il mondo ha scelto di celebrare forse più per tranquillizzare se stesso che per raccontare la realtà.
E mentre lasciamo sbiadire Gaza dai nostri pensieri, c’è un’altra guerra che sembra essersi trasformata in un rumore di sottofondo: quella tra Russia e Ucraina. Una guerra che ha perso il titolo principale delle prime pagine ma che continua a generare orrore, sofferenza e violazioni gravissime.
Una delle pagine più disturbanti, e forse meno discusse degli ultimi mesi, riguarda i bambini ucraini deportati in Russia. Migliaia. Portati in centri di “rieducazione”, separati dalle famiglie, immersi in programmi che cancellano deliberatamente la loro identità. In alcuni casi, secondo le denunce ucraine, addestrati direttamente alla logica militare, pronti – una volta maggiorenni – a essere arruolati. Una ferita aperta nel cuore dell’Europa, che coinvolge minori trasformati in strumenti di Stato. E che pure non trova più spazio, non genera più lo stesso sgomento collettivo di un anno fa.
Perché? Cosa è successo? La risposta più onesta è forse la più amara: ci siamo stancati.
Non stancati di soffrire, ma stancati di assistere al dolore degli altri. Sovraccaricati da troppe guerre, troppe notizie, troppe tragedie che il nostro sistema emotivo non riesce più a contenere. Così smettiamo. Smettiamo di indignarci, di informarci, di protestare. Ci convinciamo che “tanto non cambia nulla”. Passiamo oltre. E quel “passare oltre” è diventato la vera cifra del nostro tempo.
Siamo entrati in una fase in cui la distanza non è solo geografica, ma emotiva. Gaza e l’Ucraina ci arrivano come notifiche: vibrazioni sullo schermo che durano il tempo di una lettura veloce, di un commento impulsivo, di una condivisione senza approfondimento. In questo contesto, un cessate il fuoco viene percepito come una fine, non come una tregua precaria. La deportazione di bambini viene vista come una “notizia già letta”, non come un crimine in corso.
E questo non è solo un problema politico o mediatico: è un problema umano.
Le tragedie, oggi, competono tra loro. Chi fa più rumore vince qualche giorno di attenzione. Chi stanca il pubblico perde. Gaza è stata percepita come “troppa sofferenza per troppo tempo”. L’Ucraina come “la guerra di cui non si vede la fine”. E così il velo dell’oblio cala, quasi in automatico, quasi per autodifesa.
Ma proprio qui sta il punto: la nostra capacità di ricordare non è solo una questione morale. È una forma di responsabilità civile. Le guerre non finiscono quando noi smettiamo di parlarne. Gli ostaggi non tornano a casa perché noi abbiamo deciso di distrarci. I bambini deportati non riacquistano la propria identità solo perché il nostro feed ha scelto altri orizzonti.
Se la sofferenza degli altri diventa un fastidio, una noia, un’abitudine, allora abbiamo un problema molto più grande delle guerre stesse: abbiamo perso il senso dell’empatia come strumento collettivo, come bussola.
E allora questo editoriale vuole essere un invito brutale ma necessario: non normalizziamo l’orrore. Non archiviamo Gaza perché c’è stata una firma su un documento per metà simbolico. Non archiviamo l’Ucraina perché abbiamo visto troppe mappe, troppe analisi, troppe bandiere blu e gialle nei profili Instagram.
Non lasciamo che il mondo ci abitui alla disumanità.
La memoria non è un talento: è un esercizio. Richiede scelta, volontà, partecipazione.
Serve tornare a chiedersi ogni giorno:
Che fine hanno fatto le persone di cui parlavamo? Cosa sta succedendo davvero? Perché non ne parlano più?
Non perché il mondo dipenda da noi, ma perché la nostra coscienza sì.
In un’epoca in cui tutto sembra durare la metà del tempo che merita, la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare è restare. Restare presenti, restare informati, restare coinvolti. Non scappare davanti al dolore perché ci toglie il fiato. Non in nome del pessimismo, ma in nome dell’umanità.
Le guerre continueranno finché il mondo le tollererà. E il mondo le tollererà finché le dimenticheremo.
Oggi più che mai, ricordare è una forma di resistenza.
Immagina AI