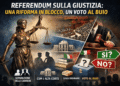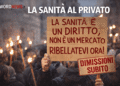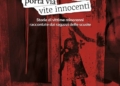Il 10 agosto 1944 a Piazzale Loreto i nazifascisti fucilarono quindici partigiani. Dall’attentato di viale Abruzzi al ruolo di Saevecke, i nomi delle vittime, il vilipendio dei corpi, la memoria e il monumento.
«Il sangue di piazzale Loreto lo pagheremo molto caro.» La frase attribuita a Benito Mussolini al vicecapo della Polizia Eugenio Apollonio suona come una cupa premonizione. Milano è nel cuore della RSI, tra occupazione tedesca e repressione. La Resistenza agisce, la città resiste, la violenza monta.
L’8 agosto 1944 esplodono due ordigni contro un camion tedesco in viale Abruzzi 77. Nessun militare tedesco muore; le vittime sono civili italiani (sei, forse sette) e gli 11 feriti vengono in parte ricoverati al Niguarda.
L’azione viene attribuita ai GAP, ma Giovanni Pesce la smentirà sempre: manca la rivendicazione, mancano le tipiche modalità partigiane. Anche il Tribunale Militare di Torino (processo Saevecke, 1998-1999) considererà plausibile l’ipotesi di un pre-testo costruito per giustificare un eccidio.
La fucilazione dei quindici
All’alba del 10 agosto 1944 quindici antifascisti vengono prelevati da San Vittore e portati in Piazzale Loreto. Il plotone è composto dai militi del gruppo Oberdan della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti, agli ordini del capitano Pasquale Cardella, su disposizione dell’SD tedesca guidata dal capitano delle SS Theodor Saevecke.
Alle 06:10 la fucilazione. Segue l’oltraggio dei corpi, esposti fino a sera sotto il sole, con un cartello infamante: “assassini”. I passanti sono costretti ad assistere. Le autorità religiose intervengono: il giovane sacerdote don Giovanni Barbareschi benedice le salme, raccoglie i messaggi nelle tasche, viene allontanato.
Gian Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Tullio Galimberti, Vittorio Gasparini, Emidio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo, Vitale Vertemati.
Operai, tecnici, impiegati, ufficiali, partigiani: la spina dorsale civile di una città che non si piega.
Le immagini sono insopportabili: corpi accatastati, mosche, silenzio forzato. Il poeta Franco Loi, bambino del Casoretto, parlerà di “uomini gettati sul marciapiede come spazzatura e altri uomini in nero che facevano la guardia”. Perfino il prefetto fascista Piero Parini scrive a Mussolini denunciando un’esecuzione irregolare e l’onda di ostilità che monta in città.
I responsabili: Saevecke e la “Muti”
-
Theodor Saevecke, capo dell’SD a Milano, passato alla storia come il “boia di Piazzale Loreto”, verrà condannato all’ergastolo (Torino, 9 giugno 1999). Non sarà estradato: muore libero in Germania nel 2000.
-
La Legione Autonoma Mobile Ettore Muti esegue l’ordine: in due casi (Soncini e Temolo) la fuga è stroncata a colpi d’arma da fuoco, i corpi riportati nel mucchio.
Memoria: il quadro di Aligi Sassu e il monumento
Nel 1944 Aligi Sassu dipinge “I martiri di Piazzale Loreto (La guerra civile)”, oggi alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma: materia, sangue, dolore, un urlo cromatico che chiede pace.
Sul luogo dell’eccidio prima un cippo, poi – dall’agosto 1960 – il monumento di Giannino Castiglioni: bassorilievo frontale, elenco dei quindici, data incisa. Una pietra d’angolo della memoria milanese.
Il 29 aprile 1945 gli italiani vedono in Piazzale Loreto i cadaveri di Mussolini, Claretta Petacci e di altri gerarchi RSI. Don Barbareschi torna a benedire anche quelle salme. La storia, a volte, riapre lo stesso palco per cambiare copione.
-
8 agosto 1944 – Viale Abruzzi: esplosione contro camion tedesco, civili uccisi, nessun militare morto.
-
10 agosto 1944, ore 06:10 – Piazzale Loreto: fucilati 15 antifascisti, corpi esposti fino a sera.
-
1960 – Inaugurato il monumento di Castiglioni.
-
9 giugno 1999 – Ergastolo a Saevecke in Italia (in contumacia).
-
16 dicembre 2000 – Saevecke muore in Germania.
Ricordare Piazzale Loreto non è un rito polveroso. È educazione civica: distingue la giustizia dalla vendetta, la legge dal terrore, la resistenza dalla sopraffazione. Tenere accesi i nomi dei quindici significa difendere la Costituzione nata dall’antifascismo.
Memoria non è passato: è difesa del presente.
In quelle ore Milano scoprì che la barbarie esige spettatori. L’antidoto è non distogliere lo sguardo.