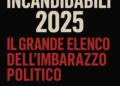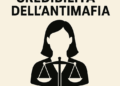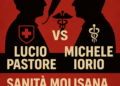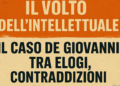Quale futuro?
Un cambiamento duraturo richiede trasformare la cultura organizzativa, con pratiche inclusive di assunzione, modelli di lavoro flessibili e sistemi di valutazione sensibili al genere. In questo quadro, la collaborazione pubblico-privato è essenziale per amplificare l’impatto e costruire ecosistemi inclusivi.
Il business sta esportando la meritocrazia dagli Stati Uniti a tutte le economie ad elevata tecnologia, esternalizzando l’ideologia del management (talmente penetrata anche in Italia da far cambiare il nome del ministero “dell’Istruzione” in “ministero dell’Istruzione e del Merito”) con tutto il suo insieme di principi operativi di gestione e di governance, ben diversi da quelli di matrice democratica, che avevano improntato l’imprenditoria del secolo passato.
Non è difficile diagnosticare le dinamiche fenomenologiche: mentre la trasformazione democratica si è realizzata attraverso grandi lotte sociali, la grande trasformazione etica e culturale che il business sta operando nel mondo si sta compiendo nell’indifferenza (quasi) generale. Come rimarcato più volte dal prof. Luigino Bruni1 i problemi riguardano l’ideologia del management, che arriva ovunque presentandosi come tecnica, e quindi come qualcosa di necessario e di non ideologico.
A fronte del linguaggio tecnico dell’ideologia del management si dovrebbe opporre drasticamente quello più conferente (perché laico) dell’inclusione. Di fatto le istanze di inclusione finiscono con il naufragare in vacui interventi parcellizzati in quei settori dove la rappresentatività ai tavoli dei decisori è esponenziale. Pochi e sempre più marginali.
Nell’ ambito delle politiche socio-economiche la parola “inclusione”, utilizzata spesso in modo superficiale, posta il baricentro del problema verso un orizzonte più vasto che involge anche le minoranze e non solo di genere, con la conseguenza di banalizzarne il vero significato.
L’inclusione autentica si basa sul rispetto relazionale, ovvero sulla capacità di riconoscere e valorizzare l’unicità di ogni persona, la quale deve essere accolta, valorizzata, libera di esprimersi e avere le stesse possibilità di accesso all’istruzione, al lavoro, ai servizi, alla vita sociale e politica.
Sono passati ormai dieci anni da quando le Nazioni unite hanno adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, un impegno condiviso da tutti i paesi dell’Onu per affrontare le grandi sfide globali attraverso un approccio integrato e multidimensionale. I Sustainable Development Goals (SDGs) coprono una vasta gamma di ambiti – dalla lotta alla povertà e alla fame, all’istruzione di qualità, alla parità di genere, alla lotta al cambiamento climatico e al degrado delle risorse naturali – e richiedono una profonda trasformazione delle politiche, dei modelli economici e dei comportamenti sociali. Gli indicatori statistici permettono non solo di monitorare i risultati raggiunti, ma anche di evidenziare gli squilibri e le disuguaglianze, identificare le aree più critiche, orientare le politiche pubbliche e rendere conto ai cittadini degli impegni presi.
Da tutto ciò emerge con chiarezza come nel contesto dell’Agenda 2030 la statistica ufficiale non sia soltanto uno strumento di analisi, ma diventa un elemento essenziale di governance, fornendo l’evidenza necessaria per orientare le politiche, allocare le risorse in modo efficace e promuovere una cultura della valutazione basata sui dati. In questa prospettiva, la produzione di informazioni rappresenta anche un’occasione per rafforzare la stretta collaborazione tra istituzioni statistiche nazionali, organismi internazionali, enti di ricerca e società civile, un ingrediente fondamentale per le politiche di governo nel perseguimento degli obiettivi dell’Agenda.
Ciò tenendo in debito conto che, come stigmatizzato dal Fondo Monetario Internazionale2, la riduzione della disparità di genere nei mercati del lavoro potrebbe incrementare il PIL dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo di quasi l’8%. I benefici di una totale eliminazione del divario di genere sarebbero ancora maggiori, con un potenziale aumento del PIL in queste nazioni pari in media al 23%
Concludo con un riferimento all‘Ipsos Equality Index 20243, indicativo delle attese che animano di fiducia le nuove generazioni e, pertanto, importante per comprendere che un futuro possibile sarebbe ancora ipotizzabile.
Per l’Ipsos Equality Index 2024, i giovani sono generalmente più sensibili rispetto agli adulti sul tema delle disuguaglianze sociali e riconoscono maggiormente le discriminazioni subite da donne (31% tra i Gen Z contro il 23% dei Baby Boomers), persone LGBTQIA+ (28% contro il 20%), persone con neurodiversità (23% contro il 17%) e persone di diverse religioni (15% contro il 9%). All’interno della Generazione Z si nota però un divario di genere. Infatti, lo studio mette in luce una differenza piuttosto marcata tra ragazzi e ragazze della Generazione Z riguardo alla percezione delle discriminazioni. Infatti, le ragazze della Gen Z dimostrano una sensibilità molto più spiccata rispetto ai loro coetanei maschi, mostrando una maggiore consapevolezza delle disuguaglianze subite dalle diverse categorie. Se le donne della GenZ si dimostrano più critiche rispetto alla media globale, esprimendo opinioni che si discostano in modo evidente da quelle delle generazioni più anziane, al contrario le opinioni degli uomini della GenZ rimangono più vicine a quelle delle persone più anziane.
Questa divergenza di opinioni tra uomini e donne all’interno della Generazione Z è confermata anche da altri studi Ipsos, che evidenziano proprio come ci sia un divario generazionale in crescita per quanto riguarda la percezione delle disuguaglianze.
Secondo l’Ipsos Equality Index 2024, a livello globale, la maggioranza dei cittadini ritiene che si debba fare di più per promuovere l’uguaglianza. Quasi la metà della popolazione (47%, 42% in Italia) crede che gli sforzi per raggiungere questo obiettivo debbano essere intensificati, a dimostrazione di una diffusa consapevolezza che il percorso verso una società più equa è ancora lungo , ma possibile. Solo una minoranza, una persona su cinque (19%), pensa che si sia andati troppo oltre, indicando una certa resistenza verso un cambiamento radicale in questa direzione.
Sempre a livello globale, il 42% delle persone crede che il successo personale dipenda principalmente dai propri meriti e sforzi. Questo dato è in aumento rispetto al 2023 (+1%). Al contrario, il 30% ritiene che il successo sia determinato da fattori esterni, al di fuori del proprio controllo. Questa opinione è in diminuzione rispetto all’anno precedente (-1%).
Analizzando i dati per fasce d’età, emerge un divario generazionale significativo. La Generazione Z è meno propensa a credere nella meritocrazia rispetto ai Baby Boomers. La differenza tra le due generazioni è di 11 punti percentuali, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2023.
La maggioranza dei cittadini (67%) ritiene che i governi abbiano la responsabilità principale di agire per ridurre le disuguaglianze. Questa opinione è particolarmente diffusa in Indonesia (82%), Perù e Corea del Sud (77%). Gli Stati Uniti, con il 51%, registrano il dato più basso tra i 29 Paesi analizzati. Mentre un quarto della popolazione totale intervistata (26%) crede che i media abbiano un ruolo importante nell’affrontare le disuguaglianze, seguiti dai datori di lavoro (24%), genitori e insegnanti (22%) e responsabilità individuale (21%).
Anche in questo caso si osserva un divario generazionale: i Baby Boomers (71%) e la Generazione X (69%) sono più propensi a credere che i governi debbano essere i principali attori nella lotta alle disuguaglianze, rispetto ai Millennials (66%) e alla Generazione Z (63%).
Il calo della fiducia nella meritocrazia, soprattutto tra le giovani generazioni, è un segnale preoccupante. Questo dato conferma come i giovani percepiscano una crescente disuguaglianza e una minore mobilità sociale, dove le opportunità di successo sono limitate da fattori esterni come la provenienza sociale, la ricchezza familiare o la discriminazione.
La crescente sfiducia nelle istituzioni da parte delle giovani generazioni dovrebbe essere un ulteriore campanello d’allarme per i governi, spingendoli a intraprendere azioni concrete per contrastare le disuguaglianze e riconquistare la fiducia dei giovani.
La società del pianeta avrà raggiunto la civiltà quando potrà attribuirsi l’attributo “umana”. Quando ciascuno condividerà i valori più profondi: dignità di ogni uomo e donna, solidarietà con i bisognosi di aiuto, lotta per la giustizia, centralità della dimensione interiore e spirituale al servizio gratuito per rispetto altrui, avversione coraggiosa al potere che diventa violenza, esclusione, sopraffazione, sterminio, alla ricchezza che condanna le persone e il pianeta alla distruzione.
Seconda e ultima parte
1 Ex multis: https://www.perunaltracitta.org/homepage/2019/03/16/meritocrazia-luguaglianza-non-e-piu-una-virtu/
2 INTERIM GUIDANCE NOTE ON MAINSTREAMING GENDER AT THE IMF ( http://www.imf.org/external/pp/ppindex.aspx
International Monetary Fund)