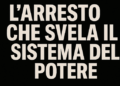Lo sterminato elenco di vittime delle Brigate Rosse riporta anche il nome di un avvocato, Fulvio Croce. Partigiano dal 1943 Croce nel 1968 fu eletto presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino. E si trovò ad affrontare uno dei processi ad alcuni membri delle Br tra cui Curcio, Gallinari, Franceschini e Ferrari. Quest’ultimo, nell’udienza del 1976, a nome anche degli altri imputati dichiarò che revocavano il mandato ai loro legali, che rifiutavano ogni assistenza legale e minacciarono di morte ogni avvocato che avrebbe accettato il mandato di “difensore d’ufficio”.
Fulvio Croce accettò l’incarico e ribadì uno dei principi fondamentali del diritto e della civiltà: il diritto alla difesa è inviolabile, persino dallo stesso imputato, e un processo deve tenersi seguendo le garanzie costituzionali e del diritto chiunque sia l’imputato, la civiltà giuridica e i diritti umani non devono conoscere eccezioni e limiti. Un coraggio che pagò con la vita il 28 aprile 1977.
Nel Paese di Fulvio Croce, nello Stato che dovrebbe basarsi su quel che Croce ha difeso fino al sacrificio della vita (e sulla memoria spesso mancata di questo sacrificio si dovrebbe aprire una riflessione doverosa ed enorme), il 6 agosto 1980 la mafia uccise il giudice Gaetano Costa. Un magistrato coraggioso, tra i primi a lottare contro la mafia fino al sacrificio della vita, spesso non ricordato, dalla memoria considerata minore da taluni. E anche qui la riflessione dovrebbe essere doverosa ed enorme.
Ci sono, poi, memorie, che sconcertano e suscitare reazioni. Ma, sarà stato il caldo agostano e il clima estivo, così non è stato. In occasione dell’anniversario di quest’anno dell’assassinio mafioso di Costa l’Anm (Associazione Nazionale Magistrati) ha pubblicato dei post social in cui afferma che la responsabilità sarebbe stata di non meglio specificati «avvocati dei mafiosi» addossando al giudice Rocco Chinnici la responsabilità di quest’accusa. «Ora, l’Anm pubblica il post anche su Instagram, che tra i vari social non è il più istituzionale – sottolinea Errico Novi su Il Dubbio – È la piattaforma utilizzata dai ragazzi per scambiarsi e proiettare immagini nel modo più vario. Messa lì, l’accusa agli avvocati che 45 anni fa sarebbero stati “complici” nell’omicidio di un magistrato diventa fatalmente un modo per far passare – anche tra un pubblico giovane e non necessariamente espertissimo, diciamo, di procedura penale – il messaggio per cui gli avvocati sono sostanzialmente mafiosi». Nel Paese di Fulvio Croce, che fu servito fino al sacrificio della vita dal partigiano e avvocato Fulvio Croce.
Damiano Aliprandi, giornalista di Il Dubbio, sulle pagine del quotidiano e in un post facebook ricostruisce quegli anni e smonta la tesi pubblicata dall’Anm rimandando a ben altre direzioni, circostanziate e testimoniate, i pesi di quel periodo. «Come ricordò anche il figlio – scomparso l’anno scorso – Michele Costa, tra l’altro avvocato di fede garantista, la morte del padre sfociò perché osò rompere, in completa solitudine, “quel patto non scritto tra le cosche e il palazzo di giustizia di Palermo”» racconta Aliprandi l’8 agosto. «Nel gennaio del 1978 fu nominato procuratore capo di Palermo e la reazione del “Palazzo” fu, in larga misura, negativa, tanto da far sì che si ritardasse la sua immissione in possesso sino a luglio di quell’anno. Nel breve periodo di sua gestione della Procura di Palermo, avviò una serie di delicatissime indagini nell’ambito delle quali, sia pure con i limitati mezzi all’epoca a sua disposizione, tentò di penetrare i santuari patrimoniali della mafia – riporta Aliprandi – Come ha ricordato Paolo Borsellino in un’intervista reperibile su Raiplay, il primo a intuire l’importanza investigativa dei conti bancari fu proprio Costa. Ha spiegato che all’interno della Procura di Palermo si erano manifestati contrasti riguardo alla convalida dei fermi e degli arresti dei numerosi imputati. Diversi sostituti procuratori ritenevano che il rapporto esistente non fornisse abbastanza elementi per procedere efficacemente. Nonostante queste divergenze, il procuratore Costa convalidò gli arresti, ma fu ucciso poco dopo».
«Il figlio di Costa sottolinea che “una rilettura dei suoi “diari” consente di avere la misura del suo isolamento e della sua sovraesposizione; farebbe individuare, inoltre, posizioni, all’interno del palazzo, che si è voluto interessatamente ignorare” – prosegue l’articolo pubblicato su Il Dubbio – Precisa che l’isolamento non deve intendersi come la naturale “solitudine” del giudice che è, e deve essere, “solo” nelle sue decisioni, ma come vittima di una azione costante e penetrante finalizzata a creare un fronte contrario alla sua strategia e a comunicare all’esterno che, se eliminato, i suoi successori muteranno indirizzo. Prosegue Michele Costa: “Nel giugno del 1983 Chinnici confida a molti (troppi evidentemente) di avere deciso di unificare le indagini sugli omicidi di Reina, Mattarella e La Torre. La decisione ha un significato preciso: la causale comune va ricercata negli appalti e nella politica. Chinnici muore appena un mese dopo”. Per completare il quadro drammatico, dopo la morte di Chinnici, in un’audizione del settembre 1983, innanzi al Csm, su quel punto Giovanni Falcone commenterà: «Il collega Chinnici prendeva appunti su tutti gli episodi che gli apparivano inconsueti e questo perché temeva che le persone che potessero volere la sua morte avrebbero potuto annidarsi anche all’interno del palazzo di giustizia. Egli mi sollecitava a fare altrettanto, dicendomi che in caso di una mia morte violenta gli appunti avrebbero potuto costituire una traccia per risalire agli assassini». Come è noto, Giovanni Falcone seguirà il consiglio di Chinnici e annoterà tutti i problemi interni al palazzo di giustizia. I cosiddetti “diari di Falcone”, però, non sono mai stati resi pubblici, tranne una parte pubblicata sul Sole 24 Ore dalla giornalista Liliana Milella. E sappiamo che Paolo Borsellino, a sua volta, farà lo stesso utilizzando la famosa agenda rossa. Mai trovata, assieme ai documenti che aveva nella borsa».
«Il 6 agosto 1980, mentre passeggiava da solo e a piedi, Gaetano Costa rimase vittima di un agguato tesogli nel centro di Palermo. Nessuno è stato condannato per la sua morte ancorché la Corte di assise di Catania ne abbia accertato il contesto individuandolo nella zona grigia fra affari, politica e mafia. Il processo ha chiarito che la firma solitaria sulla convalida degli arresti non era l’unico movente, ma lo ha certamente sovraesposto» conclude Aliprandi.
«Un sostituto procuratore è indicato come «servo della mafia», impegnato a diffondere calunnie e sabotare le inchieste più delicate – si legge in un post facebook di Damiano Aliprandi del 9 agosto in cui si ricostruisce il contenuto dei diari del giudice Costa – Attorno a lui c’è un contesto che non si riduce a singoli “infedeli”, ma a un meccanismo che avvolge intere indagini: dal caso Mattarella a quello Sindona, fino alle reti di protezione dei cugini Salvo, imprenditori mafiosi. Senza dimenticare altri due magistrati, ricorrenti anche ai tempi di Giammanco e oltre, indicati come degni emissari di quel sostituto procuratore “servo dei mafiosi”».
«A leggere quelle pagine oggi, il sospetto è inevitabile: l’esplosivo che uccise Chinnici non venne piazzato solo in via Giuseppe Pipitone, ma era già annidato da tempo nelle stanze del Palazzo di Giustizia di Palermo. All’epoca un vero e proprio centro occulto di potere. Non può non evocare quelle poche annotazioni di Giovanni Falcone (purtroppo solo una parte ne conosciamo), così come le parole di Borsellino dette poco prima di essere trucidato in via D’Amelio a sua moglie Agnese: sarà la mafia a ucciderlo, ma perché i suoi colleghi e altri lo permetteranno. Finché non si farà chiarezza su ciò che accadde in quel Palazzo di Giustizia durante il “ventennio” corleonese, resteremo tutti prigionieri di un sistema chiuso che non lascia serenamente respirare nemmeno i tanti magistrati seri e perbene» conclude Aliprandi il post del 9 agosto sui diari del magistrato Gaetano Costa.