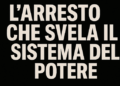C’è un piano. Un altro, sì. Sempre di Donald Trump e lo vende al mondo come un’idea visionaria: trasformare Gaza in una “Riviera del Medio Oriente”, un paradiso artificiale fatto di resort scintillanti, casinò, grattacieli, centri tecnologici, spiagge private e ville da copertina. Un futuro che luccica sulle brochure e nelle immagini generate dall’intelligenza artificiale, ma che ha l’odore acre della polvere e del sangue. Perché Gaza, prima di essere una cartolina, è ancora oggi una distesa di macerie.
Trump promette miliardi, pacchetti di aiuti e perfino 5.000 dollari per ogni palestinese disposto a lasciare la propria casa. Un incentivo alla fuga, venduto come “nuovo inizio”, condito da affitti pagati per quattro anni, cibo per dodici mesi e “token digitali” per riscattare proprietà che, nella realtà, non esisteranno più. È un piano che parla il linguaggio dei mercati, non quello dell’umanità: comprare la disperazione, monetizzare lo sradicamento, barattare la dignità per un biglietto di sola andata.
La chiamano ricostruzione, ma ricostruire cosa? Non è pace, è sostituzione. È l’idea che bastino una piscina a sfioro e qualche hotel a cinque stelle per cancellare una storia, un popolo, un’identità. Gaza deve diventare un luogo da vendere, non più da vivere. La tragedia vera è che un progetto simile riesca persino a sembrare credibile, accettabile, persino seducente per chi decide. Siamo arrivati al punto in cui il dolore viene trattato come una variabile economica, ridotto a un file Excel con colonne di costi e ricavi.
E mentre Trump sogna la sua Las Vegas sul Mediterraneo, Netanyahu annuncia senza esitazione la sua intenzione di occupare la Cisgiordania. Nessun pudore, nessuna mediazione, nessun freno. È l’ennesimo pezzo di terra strappato con la forza, come se la geografia potesse essere riscritta a colpi di bulldozer.
Noi, intanto, assistiamo con preoccupazione ma anche con profondo orgoglio alla Global Sumud Flotilla che sfida il silenzio e l’ingiustizia, nella speranza che la repressione non fermi la voce della solidarietà e che chi ostacola la pace venga fermato, non chi la difende. Ricordiamo che a bordo non ci sono politici, generali o mercanti d’armi ma ci sono medici, attivisti, giornalisti, cittadini comuni. Uomini e donne che hanno scelto di esporsi in prima persona, sapendo bene che potrebbero essere fermati, intercettati, respinti, forse perfino arrestati.
E noi? Noi governi occidentali, noi che firmiamo dichiarazioni solenni e proclami di pace, cosa facciamo? Guardiamo. Commentiamo. Alziamo sopracciglia e scendiamo a compromessi. Siamo diventati esperti nell’arte dell’attendere, del non decidere, del non disturbare. Ci riempiamo la bocca di parole come “diritti umani” e “pace duratura” e poi, di fronte a piani che trasformano un popolo in un problema logistico, tacciamo. Non alziamo la voce. Non prendiamo posizione. Non difendiamo nessuno. L’Occidente è forte quando deve stilare rapporti, debole quando deve difendere principi.
Nel frattempo, a Gaza, i bambini scelgono le canzoni per i propri funerali. Non per i compleanni. Non per le feste di fine anno scolastico. Per i funerali. Questa è la fotografia che dovremmo avere davanti agli occhi ogni volta che qualcuno pronuncia la parola “ricostruzione”. Bambini che vivono sapendo che probabilmente non vedranno l’adolescenza, che imparano a convivere con la morte prima ancora di conoscere la vita. E noi, qui, che scorriamo le loro storie come se fossero un feed qualsiasi, tra un video di ricette e un reel di vacanze.
Siamo diventati consumatori di tragedie: guardiamo, sospiriamo, commentiamo e passiamo oltre. Gaza è diventata un contenuto che si aggiorna ogni giorno, una cronaca infinita che riempie i telegiornali e svuota le coscienze. Le immagini di distruzione ci scorrono davanti come un rumore di fondo, e mentre ci abituiamo all’orrore, qualcuno già pianifica piscine, centri commerciali e stabilimenti balneari. È questa la pace che ci propongono: una pace fatta di cemento, non di giustizia.
E se i nostri governi fossero stati capaci, oggi non saremmo a questo punto.
Capaci non significa potenti: significa umani. Significa avere il coraggio di fermare le guerre invece di finanziarle, di difendere i civili invece dei mercati, di scegliere la dignità invece della convenienza diplomatica. Ma i governi non lo hanno fatto. Non lo fanno. Non lo faranno. Sono ostaggi dei propri calcoli, paralizzati dalla paura di disturbare equilibri che, in realtà, non esistono più.
La verità è che Gaza è uno specchio. Guardarla significa guardarci dentro, e quello che vediamo è terribile. Vediamo un’umanità che ha smesso di indignarsi, che misura il valore della vita in dollari, pacchetti di aiuti e token digitali. Vediamo un mondo in cui i diritti si negoziano come contratti, in cui la memoria di un popolo vale meno di un progetto immobiliare. Vediamo governi che non governano, istituzioni che non proteggono, società che non sentono più.
E allora la domanda è inevitabile: che razza di umanità siamo diventati?
Siamo quelli che permettono che i bambini scelgano le canzoni dei loro funerali.
Siamo quelli che accettano resort e casinò al posto di giustizia e ricostruzione.
Siamo quelli che si commuovono per un video e poi tornano alla cena.
Eppure, nonostante tutto, non è troppo tardi. Lo diventerà quando smetteremo di parlare, quando non resterà più nessuno disposto a raccontare che Gaza non è un progetto urbanistico, non è un rendering, non è una brochure. Gaza è un popolo, una storia, una memoria collettiva. E finché ci saranno bambini che sanno ancora cantare, dovremmo sentirci in dovere di fare in modo che possano scegliere una canzone per la vita, non per la morte.
Perché se accetteremo che Gaza diventi un resort, se accetteremo che il dolore si trasformi in business, allora non sarà solo Gaza a sparire. Spariremo noi.