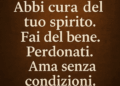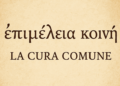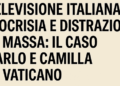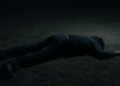Catania rappresenta uno degli esempi più emblematici di come la cultura mafiosa sia divenuta un sistema di potere radicato e trasversale. Un sistema silente, apparentemente legale e condiviso, ma nella sostanza illegale, fondato su connivenze diffuse e su un intreccio che lega criminalità organizzata, politica, imprenditoria, istituzioni, informazione e massoneria.
A Catania l’illegalità non è un’eccezione: è diventata un fattore endogeno, una componente strutturale del potere cittadino.
Certo, esistono ancora le cosche mafiose tradizionali, ma da decenni si è affermata una criminalità parallela, più sottile e più pericolosa, realizzatasi attraverso la saldatura trasversale di interessi tra settori del mondo politico, istituzionale ed economico.
Un patto non scritto che ha avuto un obiettivo chiaro: gestire le risorse pubbliche in modo verticistico, a vantaggio di pochi, lasciando interi quartieri nel degrado culturale, economico e antropologico.
La mafia dei clan ha trovato sponde solide nella criminalità economica e politico-amministrativa, in quella rete di colletti bianchi che ha garantito copertura, consulenze e rispettabilità.
Per anni, i Prefetti e i vertici delle Forze dell’Ordine sono stati scelti dalla politica seguendo un criterio implicito ma chiaro: non disturbare i manovratori.
Solo in rari casi qualcuno ha osato rompere il muro del silenzio. In altri, questi rappresentanti dello Stato sono stati cooptati nel sistema, godendo di favori, incarichi e promozioni.
Un meccanismo di potere che, invece di contrastare l’illegalità, l’ha legittimata, alimentando il senso di impunità e rassegnazione tra i cittadini.
Collante di questo sistema di potere è la massoneria, discreta ma onnipresente, non solo locale ma con ramificazioni di rango elevato.
Determinante anche il ruolo di alcuni professionisti: avvocati, commercialisti, ingegneri, notai, medici, agronomi.
Sono loro a fornire gli strumenti per dare parvenza di legalità a operazioni spregiudicate, per occultare arricchimenti illeciti e manipolare la gestione del territorio e delle risorse pubbliche.
Anche la magistratura, specie nel passato, non è stata immune. In molti casi si è dimostrata incapace di cogliere i fenomeni di corruzione, in altri connivente per omissione.
E la Chiesa Cattolica locale? Troppo spesso ha benedetto i potenti e le loro opere, mentre le voci di dissenso provenivano solo dalle comunità di base, isolate e ignorate.
La domanda è cruciale: Catania potrà risorgere?
La risposta è una sola: lo deve.
Non si può cedere alla rassegnazione né al fatalismo. Bisogna recuperare la capacità di indignarsi, di denunciare, di pretendere trasparenza e legalità.
La rinascita passa dalla formazione dei giovani, dalla coscienza civile dei cittadini onesti, da un’opera capillare di educazione ai valori della legalità.
Serve una nuova etica personale e pubblica, orientata al bene comune, capace di spezzare le catene di un sistema che ha reso Catania prigioniera di se stessa.
Solo allora la città potrà davvero tornare a respirare.