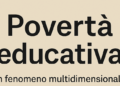L’educazione dei figli non è un compito privato riservato unicamente a chi li ha prodotti biologicamente ma è un fenomeno multidimensionale frutto del contesto familiare, economico e sociale in cui i bambini e i ragazzi vivono.
Ogni bambino/a e ragazzo/a ha il diritto di sviluppare abilità e competenze, coltivare i propri talenti e le relazioni con gli altri, realizzare le proprie aspirazioni; la mancanza di tali opportunità influenza fortemente la crescita e il benessere personale e si traduce, per la società nel suo complesso, in bassi livelli di capitale umano e di produttività, inattività diffusa, incremento dei costi di tutela e, dunque, ridotti livelli di coesione sociale.
Il tema della povertà educativa ha ricevuto un’attenzione crescente nei contesti scientifici e, per tale ragione, nel 2023 l’Istat ha istituito una Commissione scientifica interistituzionale con l’obiettivo di definire e misurare la povertà educativa e individuare le aree territoriali su cui intervenire prioritariamente e indirizzare gli investimenti.
La Commissione, composta da oltre 50 membri provenienti dal mondo accademico e da enti e organizzazioni nazionali e internazionali (tra cui Invalsi, Unicef, World Bank, Unesco, Save the Children, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Banca d’Italia, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Fondazione Con i Bambini, Anci, Inps, Cnr, Collegio Carlo Alberto e numerose università) concluderà i lavori a gennaio 2026.
Nell’indagine sul tema la Commissione ha seguito un approccio incentrato sull’accezione più ampia che la parola “educazione” assume nel vocabolario italiano, allargando lo sguardo alla pluralità di aspetti che qualificano la povertà educativa e non limitandosi al mancato raggiungimento di obiettivi di istruzione scolastica, come invece avviene per la misura della educational poverty di impronta anglosassone.
Nonostante il tema della povertà educativa sia rilevante a ogni età, particolare attenzione merita l’infanzia e l’adolescenza, le fasi della vita in cui viene costituito gran parte del capitale umano e sociale di un individuo. La povertà educativa in tali stagioni esistenziali è, del resto, spesso associata alle forme di povertà (educativa, economica, ecc.) e di esclusione sociale che si manifestano in età adulta. Una manifestazione eclatante della povertà educativa è evidente nella dispersione scolastica, sintomo della persistenza di importanti criticità nel nostro sistema di formazione.
Le criticità rilevate dall’Istat
Relativamente ai processi formativi i risultati delle indagini Istat rivelano un’articolazione territoriale del fenomeno complessa con zone caratterizzate da particolari criticità, soprattutto nel Mezzogiorno, ma anche in alcune aree del Nord. Tra le regioni che presentano valori peggiori rispetto alla media nazionale si collocano anche Piemonte (dove lo scostamento si concentra nelle aree montane e rurali) e Liguria (in tutti i contesti territoriali). Criticità si rilevano anche per la fascia appenninica dell’Emilia-Romagna e nelle aree montane della Lombardia. Rispetto a quanto emerso per la dimensione degli esiti, l’analisi della distribuzione dell’indicatore composito relativo alla carenza di risorse mostra nel complesso del territorio nazionale un minore livello di diseguaglianza, ma anche situazioni più diversificate a seconda del grado di urbanizzazione. Fatta eccezione per la Sicilia, dove su tutto il territorio regionale si registra una grande carenza di risorse, nel resto delle regioni il grado di urbanizzazione incide molto sul livello dell’indice.
In Calabria, seppure per tutti i territori la carenza di risorse è superiore alla media nazionale, lo svantaggio è più accentuato nelle zone rurali rispetto ai sobborghi e alle città.
All’opposto, in Campania sono le città che presentano situazioni problematiche in termini di risorse. Tra le regioni del Mezzogiorno, per le città della Basilicata e della Sardegna, i valori dell’indice denotano una minore carenza di risorse. Al Centro-Nord la situazione è complessivamente migliore. Nelle Città, la carenza di risorse è infatti più bassa rispetto alla media nazionale. Anche in queste aree del Paese, però, si notano diseguaglianze a seconda del grado di urbanizzazione. Le Zone rurali del Nord-ovest e del Nord-est, compresa l’area appenninica dell’Emilia Romagna, sono penalizzate. Fa eccezione il Friuli-Venezia Giulia, dove, sempre rispetto alla media nazionale, si
osserva una bassa carenza di risorse in tutto il territorio regionale, indipendentemente dal grado di urbanizzazione dei comuni. I territori che presentano valori più bassi dell’indice e, quindi, una migliore dotazione di risorse sono tutte le città della Toscana, e, nel Sud, l’Aquila e le due città della Basilicata.
Le dimensioni della povertà educativa
La povertà educativa non riguarda solo la scuola o il rendimento scolastico. Riguarda la possibilità – o l’impossibilità – di un bambino di crescere libero, stimolato, accompagnato, ascoltato. Riguarda in modo più ampio i diritti umani, l’uguaglianza, la tolleranza, l’inclusione. Riguarda la capacità della nostra società di dare a tutti le stesse opportunità.
La negazione di un’educazione piena e dignitosa può segnare una vita più di quanto si possa immaginare.
La povertà educativa è un fenomeno multidimensionale legato alla privazione nei primi anni di crescita di un bambino di risorse e opportunità per poter sviluppare pienamente le proprie capacità cognitive, emotive, relazionali e sociali.
Si verifica che, a causa di situazioni difficili o condizioni economiche di indigenza, molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in merito all’accesso a strumenti di evoluzione cognitiva come libri, materiale educativo, teatri, cinema, biblioteche, riviste e giornali, internet e tutto quanto possa rappresentare un punto di partenza per un approfondimento educativo.
Per questo, è evidente che non è una questione relegata alla scuola, ma si allarga alla vita quotidiana quando c’è assenza di stimoli, di reti affettive solide, di un ambiente che favorisca curiosità, crescita, autonomia.
La povertà educativa colpisce più duramente chi nasce in contesti fragili dove il futuro viene deciso molto prima che un bambino abbia la possibilità di scegliere.
La povertà educativa “materiale”
È la parte più facile da identificare perché parliamo di bambini e ragazzi che non hanno accesso a libri e materiale culturale, per lo più per mancanza di consapevolezza familiare o per mancanza di possibilità economiche. Non hanno un luogo tranquillo dove studiare o non hanno la tranquillità di farlo, perché spesso vivono in situazioni di grande precarietà. Non possono permettersi attività extrascolastiche né accesso a internet o a dispositivi che potrebbero favorire l’accesso a risorse educative.
Durante la pandemia da Covid-19 tutto questo è risultato più visibile: migliaia di ragazzi sono rimasti esclusi dalla didattica a distanza perché “non connessi” e per la prima volta, probabilmente, molte istituzioni hanno compreso l’importanza di provvedere a un supporto materiale in questo senso.
La povertà educativa “emotiva e relazionale”
Questa è la parte più complessa, perché non è immediata da leggere. La povertà educativa emotiva riguarda tutti quei casi nei quali non c’è un adulto di riferimento che ascolti e accompagni la crescita di bambini e ragazzi; il vivere in contesti segnati da stress, conflitti o discriminazioni.
Questo determina spesso l’incapacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni e la mancanza di fiducia in sé, negli altri e nel proprio futuro.
Qui entra in gioco la socialità: chi cresce senza reti di sostegno è a rischio tanto quanto chi non ha libri sul tavolo. E per molti minori la solitudine non è una scelta: è il risultato di povertà, migrazioni, marginalizzazione, violenza domestica, discriminazioni.
Le principali cause della povertà educativa
Date queste riflessioni, dovrebbe essere più semplice inquadrare le cause della povertà educativa, o almeno, quelle che determinano le situazioni più a rischio.
1. Povertà economica e disuguaglianze strutturali
La povertà economica aumenta drasticamente il rischio di povertà educativa.
È un meccanismo inaccettabile ma purtroppo evidente: chi nasce in un contesto fragile rischia di restarci per tutta la vita.
La povertà spesso si trasmette come un’eredità invisibile, un ciclo difficile da spezzare senza politiche pubbliche coraggiose e interventi sociali mirati.
Fragilità familiari
Le dinamiche familiari incidono enormemente sulla crescita e risentono di fragilità dettate da stress economico, violenza domestica, genitorialità non supportata.
In questi contesti, la povertà educativa prospera in quanto figlia della mancanza di inclusione, della scarsa tolleranza verso la diversità, della negazione dei diritti fondamentali.
In molte aree, soprattutto urbane e rurali, la povertà educativa è anche figlia dell’assenza di servizi scolastici di qualità e della latitanza delle istituzioni. Laddove non ci sono centri per l’infanzia, non ci sono scuole di prossimità, strutture sportive e culturali, spazi comunitari sicuri, progetti dedicati ai minori, tutto diventa più lontano e meno raggiungibile.
Povertà educativa e discriminazione di genere
Le bambine e le ragazze, in contesti difficili, sono le principali vittime di discriminazione e questo si riflette in una barriera culturale. Come dichiara che il Gender Gap Report del World Economic Forum, in molte aree a basso reddito, le bambine affrontano maggiori ostacoli nell’accesso all’istruzione, perpetuando cicli di povertà e disuguaglianza.
In molte parti del Paese le ragazze devono affrontare ancora oggi retaggi culturali, pressioni familiari, stereotipi di genere, che comportano divari significativi nelle materie STEM, nelle quali le donne rappresentano poco più di un terzo del totale dei laureati.
Gli studi dimostrano che la povertà educativa femminile non nasce solo dalla mancanza di risorse economiche, ma anche da fattori culturali e sociali che limitano libertà, ambizioni e autonomia.
Povertà educativa e territorio: quando il quartiere diventa una gabbia
Il luogo in cui si vive condiziona enormemente le opportunità educative. Quartieri senza servizi, senza spazi pubblici per i giovani, senza biblioteche, senza trasporti diventano gabbie che restringono sogni e possibilità.
In molti contesti, l’educazione è ormai una questione geografica: basta cambiare quartiere per trovare scuole con livelli completamente diversi di risorse, possibilità, prospettive. E questo non è accettabile in una società che vuole dirsi giusta.
Le conseguenze della povertà educativa
Le conseguenze sono profonde, e spesso permanenti. Gli studi scientifici concordano nel denunciare che la povertà educativa compromette lo sviluppo neurocognitivo e produce disaffezione scolastica, difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, minore partecipazione alla vita sociale, aumento del rischio di essere vittima di sfruttamento e abusi e povertà intergenerazionale.
Combattere la povertà educativa richiede l’impegno collettivo nel portare avanti iniziative che favoriscano un reale cambiamento culturale con attività di sensibilizzazione, prevenzione, formazione e percorsi di tutela per individuare precocemente condizioni di rischio.
La povertà educativa non è un problema “degli altri”. È una ferita collettiva, una perdita di talento, energia, futuro. Ogni bambino che non ha modo di sviluppare il proprio potenziale è un’opportunità di prosperità alla quale la nostra società sta rinunciando.
Per approfondire:
7ª Commissione “Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo
e sport” del Senato della Repubblica audizione del 7 ottobre 2025
Gender Gap Report del World Economic Forum
Invalsi – Fondazione terredeshommes