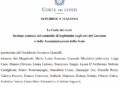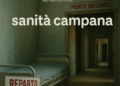Nel silenzio generale e in un’Europa troppo spesso distratta, è già realtà: i nuovi dazi americani contro l’Unione Europea sono entrati in vigore. Un terremoto che scuote l’export, mina le certezze delle imprese, e apre un nuovo fronte di tensione transatlantica.
Ma se la notizia è questa, ancora più importante è il modo in cui i diversi governi europei hanno scelto di affrontare la questione.
La Spagna di Pedro Sánchez ha risposto con un piano da oltre 14 miliardi di euro per difendere le sue filiere, sostenere i settori strategici, accompagnare le imprese nella riconversione e aprire una nuova fase di rilancio produttivo. Un’azione concreta, tempestiva, strutturale.
E l’Italia? L’Italia, ancora una volta, si chiude in un silenzio senza visione, ostaggio di slogan, calcoli elettorali e una politica ridotta a teatro quotidiano. Una differenza che non è solo tecnica, ma culturale. E che racconta – purtroppo – chi sta provando a governare il presente e chi si limita a inseguirlo.
Il premier spagnolo non è certo immune da critiche. È stato attaccato per le sue alleanze, per le concessioni fatte ai partiti regionali, per la gestione di alcune riforme sociali. Ma c’è una cosa che non gli si può negare: il coraggio della responsabilità.
Sánchez ha capito, forse prima di altri, che in un mondo in continua mutazione non basta amministrare, bisogna avere una direzione. E una direzione chiara la si dà con scelte nette, anche impopolari, con il coraggio di affrontare il conflitto, con la capacità di proteggere il proprio sistema produttivo senza chiudersi nel protezionismo.
Il piano da 14 miliardi è solo l’ultimo esempio di un governo che interpreta il suo ruolo in maniera piena: presidiare la complessità, dare risposte strutturate, difendere i più esposti.
Non si tratta solo di soldi: si tratta di una visione di Paese. E di una politica che sa ancora dire “noi”, senza abdicare alla logica delle tifoserie e dell’autopromozione.
In Italia, i dazi sono arrivati. Sono qui. Colpiscono settori nevralgici: vino, olio, formaggi, ceramica, tessile, meccanica. Eppure, nessuna risposta reale è stata ancora formulata. Nessuna manovra straordinaria, nessuna cabina di regia, nessuna interlocuzione forte con Bruxelles o con Washington.
Anzi, si moltiplicano le dichiarazioni generiche, i “valuteremo”, i “stiamo monitorando”, i “non è colpa nostra”. È come se la classe dirigente fosse intrappolata in un eterno presente, incapace di pianificare, di prevedere, di reagire con lucidità.
Questo atteggiamento riflette un vuoto più profondo: la politica italiana ha smesso di pensare a lungo termine. Si accontenta di inseguire l’onda, di gestire il consenso giorno per giorno, di occupare spazi mediatici anziché costruire soluzioni.
E così, mentre in Spagna si tutela il lavoro e si investe nella competitività futura, in Italia si attende, si rinvia, si spera che tutto si risolva da solo, o che cambi il vento. Ma il vento, spesso, porta via chi non ha radici forti.
Ciò che manca drammaticamente, oggi, in Italia, è una cultura del rischio politico e della responsabilità pubblica.
Siamo passati dalla “politica del fare” alla “politica del non perdere”. Tutto è orientato a conservare, evitare scossoni, non scontentare nessuno. Ma la storia insegna che i grandi passi avanti si fanno quando qualcuno ha il coraggio di dire: “è ora di decidere”.
La Spagna lo sta facendo. Non in maniera perfetta, non senza contraddizioni. Ma lo sta facendo. Ha capito che la posta in gioco è altissima: o si rafforzano le economie interne e si costruisce un’Europa più autonoma, o si rischia di essere schiacciati tra le superpotenze.
L’Italia invece si rifugia ancora nei vecchi schemi: l’industria arrangia, le famiglie stringono i denti, il governo si prende il merito quando va bene e dà la colpa all’Europa quando va male.
Ma fino a quando possiamo permetterci questa inerzia?
Il confronto tra Italia e Spagna è anche uno specchio dell’Europa che vogliamo. Da un lato, un Paese che non ha paura di sporcarsi le mani con la realtà, che discute, media, contratta, ma poi sceglie e agisce. Dall’altro, un Paese che si aggrappa alla retorica della sovranità per mascherare una profonda fragilità interna, una classe politica che raramente guarda fuori dai confini nazionali e troppo spesso guarda solo al proprio elettorato.
Ma in un mondo dove i confini sono diventati permeabili, dove i mercati sono interconnessi e le crisi viaggiano più veloci delle soluzioni, la vera sovranità non è l’autarchia, ma la capacità di decidere in fretta e bene.
E in questo, oggi, Pedro Sánchez è più sovrano di tanti altri leader che brandiscono la parola “patria” senza poi sapere come difenderla concretamente.
Il piano spagnolo da 14 miliardi di euro è un modello? Forse sì, forse no. Ma è, almeno, un segnale forte, un gesto politico che dice: “il governo c’è”.
In Italia, servirebbe un risveglio, un colpo d’orgoglio. Servirebbe dire basta alla retorica dell’attesa, alle frasi fatte, alla delega permanente. Servirebbe una politica che torni ad avere il coraggio di scegliere.
Perché l’alternativa non è il fallimento rumoroso, ma l’erosione lenta, silenziosa, irreversibile, di tutto ciò che un tempo ci rendeva forti: la nostra manifattura, il nostro ingegno, la nostra credibilità internazionale.
E allora, forse, non si tratta più solo di dazi. Si tratta di decidere se vogliamo ancora essere un Paese capace di guidare il proprio destino, oppure restare spettatori, aspettando che qualcun altro ci spieghi come va il mondo.
Immagine IA