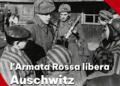A quasi vent’anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a non trovare pace. L’Italia lo ha seguito come un lungo thriller dai contorni incerti, con protagonisti controversi, colpi di scena giudiziari, silenzi pesanti ed un clima che, più che giustizia, sa di inquietudine e sospetto.
Oggi quel caso si riapre. Di nuovo. Per l’ennesima volta. Da ciò che si evince, non perchè siano emerse prove clamorose ma perché qualcuno “il supertestimone”, mai stato preso in considerazione anni fa ed intervistato più volte dalle Iene, ha riportato nuovamente parole ed azioni che sembrano in perfetta sintonia con prove e documenti per anni segretamente custoditi e non solo, perché qualcosa – o meglio qualcuno – ha deciso di alzare il velo sull’indicibile: Fabrizio Corona, attraverso un’operazione di denuncia mediatica ha portato alla luce nomi, volti, legami, omissioni. Ha fatto quello che forse avrebbero dovuto fare altri. Ma davvero serviva lui per rimettere in discussione una verità giudiziaria così fragile da incrinarsi sotto il peso di semplici domande?
Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, è il nome tornato prepotentemente al centro della scena. Cinque anni da indagato senza che l’opinione pubblica ne sapesse nulla. Eppure, già nel 2017, la sua presenza nel caso faceva discutere: il DNA rilevato sul computer di Chiara, l’ultimo accesso al PC, i messaggi scambiati. E oggi la Procura, pur avendo già bocciato due volte la riapertura, lo tiene nel mirino. Non perché manchino elementi, ma – si mormora – perché si attende solo di consolidare ciò che si sa già.
Un’indagine silenziosa che più che cercare risposte, sembra voler incastonare definitivamente pezzi già noti, come se la verità fosse lì, evidente, ma mancasse il coraggio o il momento giusto per pronunciarla. Ma allora, in tutto questo tempo, cos’è accaduto? Perché non si è parlato? Chi ha protetto chi?
È qui che emerge tutta la contraddizione del nostro sistema giudiziario. In un paese normale, quando emergono nuove piste, nuovi soggetti, nuove versioni, si indaga, si ascolta, si agisce. In Italia, invece, si archivia, si tace, si attende. E poi, magari, si punisce il capro espiatorio di turno.
Ci sono le cugine di Chiara che, secondo quanto riportato da Corona, avrebbero contattato lo stesso fotografo pochi giorni dopo l’omicidio per entrare nel mondo dello spettacolo. Sempio, che non si presenta all’interrogatorio. Rapporti interpersonali ambigui mai chiariti. Tracce trascurate, testimonianze sottovalutate, versioni comode.
E intanto Alberto Stasi, condannato a 16 anni, si trova in carcere. Forse colpevole, forse no. Ma il punto non è solo se abbia ucciso. Il punto è: lo ha fatto da solo? Era davvero lui il solo responsabile? Perché nessuno ha voluto esplorare fino in fondo la possibilità di una complicità, di una dinamica diversa? La giustizia, ancora una volta, ha preferito chiudere, piuttosto che scavare.
Il caso Garlasco è l’ennesimo esempio di una giustizia che funziona male. Male nei tempi, nei modi, nelle priorità. Un sistema che si muove tra archiviazioni frettolose e processi mediatici, tra verità ignorate e condanne di comodo. Perché in fondo – e questo è il punto più inquietante – l’obiettivo non è sempre scoprire la verità. L’obiettivo, spesso, è chiudere il caso. Dare un volto al colpevole, anche se quel volto non è quello giusto.
Una giustizia che arriva tardi, quando arriva. Che indaga poco, archivia molto, condanna troppo spesso sulla base dell’emotività collettiva più che delle prove. Che si piega alla narrazione dominante e non alla ricostruzione dei fatti.
In Italia non abbiamo bisogno di detective: abbiamo bisogno di giornalisti, influencer, outsider per riportare a galla le falle del sistema. E questo, in sé, è già una sconfitta.
E in un sistema dove la verità è ancora tutta da scrivere, è legittimo porsi anche domande scomode. Se Alberto Stasi fosse davvero innocente, o comunque non unico responsabile, che ne sarà degli 850mila euro di risarcimento che la famiglia Poggi ha ottenuto? Andrebbero restituiti? Euro per euro? Sarebbe giusto, sarebbe lecito, ma sarebbe anche terribilmente doloroso. Perché quella famiglia ha già perso tutto, ma non possiamo più ignorare che l’intero processo potrebbe essere stato condotto sulla base di una verità parziale.
Viviamo in un Paese che preferisce una menzogna rassicurante. Una verità scomoda destabilizza, costringe a rivedere sentenze, carriere, equilibri. Una menzogna rassicurante, invece, placa le coscienze. Ma a che prezzo?
La riapertura del caso Garlasco è un’occasione storica. Non solo per fare giustizia, ma per dimostrare che la giustizia in Italia può ancora guardarsi allo specchio. È il momento di abbandonare i formalismi, di smettere di temere il clamore mediatico e iniziare a fare quello che dovrebbe essere l’unico compito della magistratura: cercare la verità, fino in fondo, senza sconti, senza pressioni, senza convenienze.
Perché la verità, se non arriva, fa male. Ma se viene tradita, distrugge.