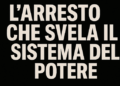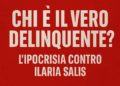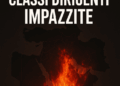Le parole contano, soprattutto quando vengono pronunciate da chi rappresenta un’istituzione pubblica. E ancora di più quando quelle parole riguardano la guerra, la morte, la responsabilità morale dell’informazione. Le dichiarazioni di Incoronata Boccia, direttrice dell’Ufficio Stampa della Rai, secondo cui “non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi”, non possono essere archiviate come un’opinione personale. Sono qualcosa di più grave: un segnale politico, un messaggio che pesa su tutto il mondo del giornalismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati.
Boccia, parlando al Cnel, ha aggiunto che “si vergogna per i giornalisti che diffondono notizie false”. Una frase che, se isolata, potrebbe sembrare condivisibile: la disinformazione è un problema serio, e combatterla è un dovere. Ma il contesto cambia tutto. Perché la sua dichiarazione non nasce nel vuoto, bensì dentro un conflitto che da oltre un anno devasta Gaza, che ha cancellato intere famiglie e che ha trasformato la verità in un campo di battaglia tanto quanto le strade bombardate.
In quel contesto, dire che “non ci sono prove” di attacchi ai civili significa prendere posizione — non per la verità, ma contro di essa.
Quando una dirigente del servizio pubblico nega o ridimensiona fatti ampiamente documentati, non sta esercitando libertà di opinione. Sta minando la fiducia nel giornalismo e nella possibilità stessa di accertare i fatti. È il meccanismo più efficace della propaganda contemporanea: non serve più dire che qualcosa è falso, basta dire che “non è provato”. È la strategia del dubbio permanente, quella che permette di rendere tutto relativo, di mettere sullo stesso piano la testimonianza diretta e la negazione interessata.
Il risultato è devastante. Perché in un’epoca in cui l’informazione è frammentata, in cui ogni video viene smentito prima ancora di essere analizzato, affermare che “non esistono prove” non significa cercare la verità, ma indebolirla.
E quando a farlo è una figura istituzionale della Rai — un servizio che dovrebbe essere garanzia di equilibrio, non di revisionismo — la questione diventa pubblica, politica, culturale.
La frase di Boccia si inserisce in una tendenza pericolosa: quella di confondere la neutralità con l’indifferenza.
Si ripete spesso che il giornalismo deve essere neutrale ma questo non significa sospendere il giudizio di fronte all’evidenza. Significa, semmai, verificare, contestualizzare, dare voce a tutte le parti senza nascondere i fatti.
Dire “non ci sono prove” quando centinaia di testimonianze, video, rapporti di ONG e agenzie internazionali raccontano un’altra realtà, non è neutralità: è negazione.
E soprattutto è mancanza di rispetto verso chi, nel frattempo, quella verità la paga con la vita.
Dall’inizio della guerra a Gaza, più di duecento giornalisti sono stati uccisi. Molti di loro non erano combattenti ma operatori di camera, reporter, fotografi. Stavano facendo ciò che una democrazia dovrebbe difendere con tutte le forze: documentare.
L’ultimo, solo pochi giorni fa, è stato colpito mentre filmava la speranza di una tregua. Aveva appena registrato un video sorridendo alla notizia che “la guerra era finita”. È morto poco dopo.
E qualcuno, a migliaia di chilometri di distanza, ha avuto il coraggio di dire che non ci sono prove.
In un mondo iperconnesso e saturo di immagini, la verità è diventata più vulnerabile che mai.
Chi controlla la narrazione, controlla la percezione dei fatti.
Ma un conto è chiedere rigore, un altro è usare il rigore come arma per negare tutto ciò che è scomodo.
Le prove, nel caso di Gaza, ci sono: video verificati da agenzie indipendenti, immagini satellitari, testimonianze di civili e medici, rapporti delle Nazioni Unite, indagini di media internazionali come Reuters, AP, Al Jazeera, BBC.
Sono tutte da mettere in discussione, certo, come ogni informazione in tempo di guerra. Ma dire che “non esistono” significa ignorare, volontariamente, la realtà.
Questo è il punto. Non si tratta di difendere una parte, ma di difendere il principio stesso di realtà.
Perché se ogni fatto può essere liquidato come “non provato”, allora qualsiasi menzogna può passare per verosimile.
E a quel punto non esiste più differenza tra un giornalista e un portavoce, tra un’inchiesta e un comunicato.
È la morte lenta della credibilità.
La Rai, per missione, dovrebbe essere il baluardo della responsabilità informativa.
Non può permettersi di giocare con le parole, né di legittimare il dubbio come strategia politica.
Un’emittente pubblica deve dare spazio al confronto, non al revisionismo.
Perché ogni parola pronunciata da chi la rappresenta ricade su tutti: sui professionisti che ogni giorno lavorano con serietà, sui giornalisti che rischiano la vita sul campo, sui cittadini che ancora credono nel diritto a un’informazione libera e verificata.
Invece, quello che emerge è un messaggio diverso: che la verità non è più un dovere, ma un’opinione; che il dolore può essere interpretato, che i morti possono essere messi in discussione.
Ed è qui che nasce la vera vergogna — non quella dei giornalisti, ma di chi, dall’interno, riduce il giornalismo a un esercizio di opportunismo istituzionale.
A completare il quadro, ci sono le immagini dei leader internazionali riuniti ai tavoli della “pace”.
Sorrisi, strette di mano, dichiarazioni solenni.
Un copione già visto.
È una pace da scenografia, fatta di frasi calibrate e di conferenze stampa, mentre sul terreno restano le macerie, i corpi e le telecamere distrutte.
E in questo spettacolo globale, la verità è la prima vittima.
Perché una pace raccontata come “successo diplomatico” serve a tranquillizzare l’opinione pubblica, non a salvare vite.
Non si tratta più solo di giornalismo. Si tratta di coscienza civile.
Negare ciò che è documentato, minimizzare la violenza, ridurre tutto a una questione di “narrative” non è prudenza: è complicità.
E chi ha un microfono, un incarico pubblico, una piattaforma, ha una responsabilità che va oltre la propria opinione personale.
Non basta più dire “mi vergogno dei giornalisti che disinformano”.
Bisogna chiedersi chi, oggi, disinforma davvero.
Chi sceglie di non vedere, di non leggere, di non approfondire.
Chi usa la parola “vergogna” per accusare, ma non per mettersi in discussione.
Ogni volta che un giornalista muore cercando di raccontare la verità, un pezzo della nostra libertà muore con lui.
E quando un’istituzione pubblica sceglie di ignorarlo, quel sacrificio diventa inutile due volte: sul campo e nella memoria.
Non serve idealizzare i reporter ma riconoscere che senza di loro non sapremmo nulla di ciò che accade davvero.
Ed è per questo che negare le prove non è solo un errore professionale, è un insulto alla loro morte.
Oggi, la vera vergogna non è di chi racconta, ma di chi tace.
Di chi trasforma la cautela in negazione.
Di chi, per convenienza o per paura, sceglie di dire che “non ci sono prove”, pur sapendo che quelle prove esistono — solo che non conviene guardarle.
La libertà d’informazione non è un privilegio, è un argine.
E ogni volta che qualcuno lo indebolisce, in nome della “prudenza” o della “neutralità”, stiamo permettendo che il potere riscriva la realtà a suo piacimento.
Non c’è nulla di più pericoloso.
E se davvero bisogna parlare di vergogna, allora sì: vergogniamoci, ma per le parole pronunciate con leggerezza, per la verità negata, per i morti dimenticati.
Perché chi sceglie di non vedere, in fondo, non è più spettatore: è parte del problema.