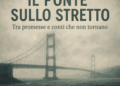Il Ponte sullo Stretto di Messina è tornato, come un vecchio fantasma che riappare ogni volta che la politica ha bisogno di una promessa impossibile da mantenere.
Non c’è dibattito pubblico, non c’è crisi di governo o campagna elettorale che non riesumi questa opera mitica, metà sogno e metà provocazione.
Da più di cinquant’anni se ne parla come di una chiave di svolta per il Sud, ma la verità è che il ponte unisce solo le parole, mai le sponde.
E oggi, ancora una volta, la divisione non è tra Calabria e Sicilia, ma tra chi scambia la propaganda per progresso e chi continua a chiedere un briciolo di logica prima di spendere miliardi.
La Corte dei Conti, invece, la logica la conserva. Ed esercita ciò che la Costituzione le affida, l’articolo 100, per chi ha ancora voglia di ricordare come funziona lo Stato: il controllo di legittimità e di gestione sugli atti del Governo.
E se trova che qualcosa non quadra — nelle carte, nei contratti, nelle coperture finanziarie — ha tutto il diritto, anzi il dovere, di fermarsi e dire: “Scusate, ma spiegate meglio”.
Non è un sabotaggio, è una garanzia. È la differenza tra uno Stato serio e uno Stato che firma assegni in bianco.
Il costo aggiornato del ponte, secondo i documenti più recenti, è di circa 13,5 miliardi di euro.
Tredici miliardi e mezzo per un ponte che ancora non esiste.
Una cifra talmente alta che potrebbe risolvere gran parte dei problemi strutturali del Sud se solo fosse spesa con intelligenza: scuole moderne, ospedali funzionanti, trasporti dignitosi, infrastrutture di base.
Ma no: in Italia si preferisce sognare in grande, anche se poi ci si sveglia sudati nel mezzo di un incubo contabile.
E mentre la Corte dei Conti chiede chiarimenti, Salvini si infuria. L’ha presa come un affronto personale, come se il Ponte fosse una sua creatura e la Corte un fastidioso revisore di condominio.
Ma la verità è che non c’è nulla di politico in una revisione contabile.
La Corte non “boccia” per ideologia — verifica, controlla, pretende trasparenza. Fa ciò per cui esiste.
E fa bene a farlo, in un Paese dove ogni grande opera rischia di trasformarsi in un banchetto per la burocrazia e per le mafie, con la differenza che alla fine il conto lo paga sempre il cittadino.
Chi oggi grida allo scandalo perché “la Corte blocca il progresso” forse dovrebbe rileggersi l’articolo 100.
La Corte dei Conti non è un partito di opposizione, è un organo di garanzia.
Serve proprio a evitare che i governi — di qualsiasi colore — facciano e disfino opere miliardarie senza trasparenza, senza controlli, senza coperture solide.
È un freno di sicurezza, come i binari del treno che impediscono di deragliare.
Chi si arrabbia per un controllo contabile dimostra di temere il controllo stesso, e questo, in politica, è già un cattivo segno.
Non c’è nulla di illegittimo nel fatto che la Corte chieda lumi su contratti stipulati senza nuova gara, su progetti tecnici datati, o su coperture finanziarie ancora ballerine.
Anzi, è il segno che un’istituzione dello Stato — una delle poche rimaste davvero indipendenti — sta facendo ciò che dovrebbe fare ogni giorno: garantire che i soldi pubblici non diventino fumo.
E allora viene spontaneo chiedersi: ma davvero serve un ponte, oggi?
O serve piuttosto un piano di ricostruzione civile e morale?
Perché se la Sicilia e la Calabria non riescono a garantire un treno puntuale, un pronto soccorso efficiente o una scuola che non crolli al primo temporale, a cosa serve un ponte di 3,3 chilometri sopra il mare?
Unire due fragilità non fa una forza, fa solo una frattura più grande.
Con 13 miliardi e mezzo si potrebbe finanziare un programma strutturale di rilancio del Sud: potenziare i trasporti interni, migliorare la sanità locale, rinnovare le scuole, creare lavoro stabile e formazione.
E invece si preferisce un colpo d’effetto, una promessa elettorale fatta di piloni e render digitali.
Perché il ponte, in fondo, serve più alla narrazione che alle persone.
È l’illusione del “fare”, anche quando il fare è solo apparire.
Ogni governo italiano, a modo suo, ha cercato di intestarsi il mito del “grande progetto”.
Ma la storia recente ci insegna che i cantieri faraonici sono spesso tombe di denaro pubblico.
L’Alta Velocità, la Salerno-Reggio Calabria, Mose, Expo, le Olimpiadi: quante volte abbiamo visto i costi raddoppiare, i tempi triplicare, e la qualità dimezzarsi?
E ogni volta, puntualmente, qualcuno si arricchisce mentre i cittadini restano in attesa.
È il Paese dei lavori infiniti e dei collaudi mancati, dove un ponte non si inaugura: si perpetua.
E allora sì, forse è il caso che la Corte dei Conti faccia da anticorpo istituzionale, prima che l’ennesimo sogno “strategico” si trasformi in un incubo contabile con l’odore della corruzione.
Molti hanno chiesto se, in caso di irregolarità, “Salvini dovrà risarcire di tasca sua”.
No, non funziona così.
La Corte dei Conti può, in teoria, stabilire responsabilità contabili e condanne per danno erariale ma solo al termine di un procedimento complesso, e solo se si dimostra un danno economico concreto causato da dolo o colpa grave.
Non basta un progetto sbagliato per mandare un ministro in bancarotta personale.
Ma è proprio qui il punto dolente: chi paga quando le cose vanno male?
Sempre gli stessi: i cittadini, con le loro tasse, con i loro servizi tagliati, con i loro treni che non passano e le scuole che chiudono.
Il ponte sullo Stretto è l’ennesima cattedrale nel deserto, costruita prima ancora che si sappia se ci sarà un deserto intorno o una città viva.
Un simbolo di quella politica che preferisce le opere “visibili” a quelle utili, le inaugurazioni alle riforme, le promesse alle manutenzioni.
Perché sistemare un ospedale non porta voti, costruire un ponte sì.
Anche se poi resterà a metà, anche se costerà il doppio, anche se servirà a pochi.
L’importante è che si veda. Che faccia rumore. Che dia l’illusione di grandezza.
E così, mentre i sindaci chiedono fondi per l’acqua potabile e gli insegnanti si comprano i gessetti da soli, si discute di un ponte che attraverserà il mare, ma non colmerà mai la distanza tra ciò che serve e ciò che si promette.
Il Ponte sullo Stretto, così com’è pensato oggi, non è un’opera ingegneristica: è una metafora.
Rappresenta il modo in cui questo Paese continua a credere che basti un’opera monumentale per redimersi dai suoi limiti.
Ma la verità è che nessuna struttura di acciaio può unire due terre che non vogliono cambiare.
Non serve un ponte tra Calabria e Sicilia: serve un ponte tra politica e realtà.
E finché la Corte dei Conti sarà costretta a ricordarci come si fa di conto, significa che il conto, quello vero, non lo abbiamo ancora pagato.