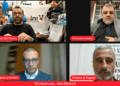La morte violenta di Pino Pinelli non è un capitolo chiuso. È una ferita ancora aperta nel corpo della Repubblica.
La settima puntata della seconda stagione di “30 minuti con…”, trasmessa su WordNews.it, ha scelto di riaprire quella finestra della questura di Milano da cui il ferroviere anarchico precipitò nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969.
In studio Paolo De Chiara, la testimonianza intensa di Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe “Pino” Pinelli e, nella parte iniziale della puntata, l’intervento di Antonino Schilirò, collaboratore di WordNews.it, costretto poi a lasciare la diretta per motivi di salute ma presente con il suo punto di vista sulla strategia della tensione e sui depistaggi di Stato.
Una seduta pubblica di memoria civile: nomi, date, responsabilità, omissioni. E una domanda che brucia ancora: perché lo Stato ha così paura della verità su Pinelli?
Dal premio Lea Garofalo a Piazza Fontana: le verità negate
La puntata si apre “da Cremona”. Tutti e tre, De Chiara, Schilirò, Claudia Pinelli, sono reduci dalla 4ª edizione del Premio nazionale Lea Garofalo, dove le sorelle Claudia e Silvia Pinelli hanno ricevuto un riconoscimento come “Testimoni del nostro tempo”.
A Cremona, però, le istituzioni locali hanno brillato per la loro assenza. Pochi amministratori, pochissimi cittadini. Stessa dinamica che avvolge da decenni la vicenda di Piazza Fontana e di Giuseppe Pinelli: la memoria c’è, ma lo Stato fa di tutto per tenerla ai margini. Claudia lo dice con una lucidità disarmante: a Cremona ha ritrovato, in altre storie di testimoni e familiari di vittime, «lo stesso tradimento dello Stato rispetto ai principi costituzionali» vissuto dalla sua famiglia.
Chi era davvero Giuseppe “Pino” Pinelli
Prima di essere un “caso giudiziario”, Pino Pinelli è stato un uomo in carne e ossa: anarchico, ferroviere, staffetta partigiana, sindacalista di base, militante pacifista e antimilitarista.
Negli anni del dopoguerra studia esperanto, sogna un mondo senza frontiere e senza guerre, vive gli anni ‘60 come stagione di diritti, movimenti studenteschi, lotte operaie. Rifiuta ogni autoritarismo, tiene insieme circoli anarchici, reti di solidarietà, collegamenti tra gruppi libertari di tutta Italia.
Non mette bombe. Non organizza stragi. Sostiene invece, anche economicamente e sul piano legale, i giovani anarchici arrestati per attentati dimostrativi, che la magistratura riconoscerà estranei alle stragi e collegati invece all’eversione neofascista di Ordine Nuovo.
Il 12 dicembre 1969, la sua ultima lettera a un compagno in carcere suona come un testamento politico:
«L’anarchia non è violenza. La rigettiamo, ma non vogliamo nemmeno subirla. Anarchia è ragionamento e responsabilità».
Poche ore dopo Piazza Fontana esplode. E quella frase diventa un atto d’accusa contro chi lo trasformerà nel capro espiatorio perfetto.
12 dicembre 1969: strategia della tensione e macchina del depistaggio
Claudia ricostruisce con precisione chirurgica il contesto:
-
più di 145 attentati nel solo 1969,
-
bombe, panico seminato ad arte,
-
il convegno dell’Hotel Parco dei Principi dove militari, fascisti, uomini dei servizi e “esperti” definiscono una vera e propria “guerra a bassa intensità” per riportare “ordine” nel Paese.
La strage di Piazza Fontana, 17 morti e oltre 80 feriti alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, è il salto di qualità: il terrorismo stragista usato per colpire i movimenti sociali, giustificare strette repressive, fermare il vento che soffiava dal ‘68. Gli anarchici sono il bersaglio ideale: frammentati, privi di una struttura gerarchica, facilmente criminalizzabili. Pinelli è il volto più noto del movimento milanese, quello che va in questura a chiedere permessi per i cortei, a garantire la legalità delle manifestazioni, a seguire i giovani incarcerati.
Per questo viene fermato, mentre si sposta in motorino tra un circolo e l’altro, invitato a seguire la volante “per alcuni accertamenti”. Entra in questura da innocente. Ne uscirà solo da morto.
Tre giorni di fermo illegale e una finestra che non racconta tutta la storia
Dal 12 al 15 dicembre Giuseppe Pinelli viene trattenuto oltre ogni limite di legge. Non è un indagato. È teoricamente un “fermo per accertamenti”. Nessun magistrato convalida. Nel frattempo nella questura di Milano circolano uomini che non dovrebbero esserci: non solo poliziotti, ma appartenenti ai servizi segreti e all’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, arrivati da Roma e rimasti in ombra per decenni.
La versione ufficiale cambia a seconda delle convenienze: prima “suicidio”, Pinelli che si sarebbe lanciato gridando “È la fine dell’anarchia”; poi “malore attivo”, l’invenzione giuridica del giudice D’Ambrosio per archiviare tutto senza colpevoli.
Claudia ricorda un dato chiave: in quella stanza c’erano almeno sei persone; l’unico testimone esterno, Lello Valitutti, sostiene da sempre che il commissario Calabresi non è mai uscito; il giudice non lo ascolta mai, nessuno lo denuncia per falsa testimonianza.
Il risultato è una sentenza che parla di “morte accidentale” e di nessun responsabile. Una formula che ancora oggi grida vendetta.
Le due lapidi, il Quirinale e una verità solo storica
A Piazza Fontana oggi ci sono due lapidi per Giuseppe Pinelli: quella degli studenti e democratici milanesi del 1977, che recita «ucciso innocente» e parla di “ucciso nei locali della questura”; quella del Comune di Milano, voluta dopo la rimozione notturna della prima nel 2007, che lo definisce «innocente morto tragicamente».
“Ucciso” e “morto” una accanto all’altra: per Claudia è un monumento perfetto all’ipocrisia italiana.
Nel 2009, al Quirinale, arriva il riconoscimento più alto: il presidente Giorgio Napolitano inserisce Pinelli tra le vittime della strage di Piazza Fontana, definendolo innocente, vittima due volte: degli infondati sospetti e di una morte senza verità giudiziaria.
In quell’incontro riservato tra la famiglia Pinelli e i familiari del commissario Calabresi si sfiora una possibile ricomposizione. Ma tutto si ferma lì. Lo Stato concede una verità storica, ma non ha il coraggio di andare oltre, di riaprire archivi, di riconoscere responsabilità precise.
Il fascismo che non è mai andato via
Nel dialogo con De Chiara, Claudia Pinelli è netta: il fascismo non è un ricordo polveroso, è un virus culturale ancora attivo. Lo si vede: nelle parole di chi riduce la Resistenza a un “capriccio”, nei tentativi di riscrivere la storia (Pasolini definito “fascista” da chi oggi governa, Via Rasella raccontata come massacro di “musicisti-medici”), nei decreti sicurezza che limitano il diritto di manifestare, criminalizzano studenti e lavoratori, trasformano il dissenso in problema di ordine pubblico, in una stampa sempre più addomesticata, che fa da megafono al potere invece di controllarlo.
Il fascismo, spiega Claudia, oggi si manifesta nella paura delle piazze, nello scherno verso gli scioperi, nello sguardo ostile rivolto agli ultimi, ai migranti, ai “diversi”. Si sconfigge solo sul piano culturale, costruendo anticorpi di memoria e consapevolezza.
Memoria collettiva, non “memoria condivisa”
Un passaggio della puntata merita di restare scolpito. Claudia rifiuta l’idea di “memoria condivisa”: non può esserci condivisione dove non c’è verità, dove i documenti restano nascosti, dove lo Stato si rifiuta di dire fino in fondo cosa è accaduto in quella stanza della questura:
«Lavoriamo per una memoria collettiva, certo. Ma condivisa no. Non c’è pacificazione senza verità».
Qui sta il senso più profondo della puntata e del percorso di “30 minuti con…”: non raccontare il passato per nostalgia, ma usare la memoria come atto politico, come strumento per leggere l’oggi, per denunciare i nuovi autoritarismi, per dare voce a chi è stato schiacciato dalla ragion di Stato.

Nella foto di copertina Claudia Pinelli, ph Antonino Schilirò