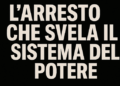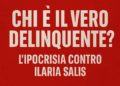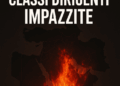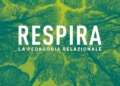La narrazione della crisi climatica sui media si nutre molto spesso di sensazionalismo, presentando il problema e i singoli eventi con titoli e toni catastrofici. Due sono i fattori che spingono in questa direzione, ha spiegato il professor Stefano Caserini in una lezione aperta presso l’Università di Parma: da un lato il bisogno di notizie forti, che catturino l’attenzione di un pubblico sempre più distratto, dall’altro la carenza di competenze che permettano una corretta lettura dei dati climatici, per loro natura multidimensionali e altamente variabili.
Per interpretare in modo attendibile la trasformazione del clima sul nostro pianeta bisogna prendere in esame intervalli temporali molto lunghi e correlare tra loro un buon numero di parametri, operazione che richiede conoscenza ed esperienza. Se si considera uno specifico episodio meteorologico o si guarda solo il breve periodo, ad esempio confrontando la variazione delle temperature medie in una certa zona da un anno all’altro, è facile andare fuori strada e virare verso un racconto iper-semplificato e sensazionalista.
Ma la tendenza all’iperbole e al catastrofismo è solo una parte della storia. All’estremo opposto troviamo narrazioni di stampo negazionista, che cercano di rimuovere o minimizzare la crisi climatica. Le evidenze scientifiche e l’esperienza collettiva rendono ormai difficile negare in toto il problema, ma è abbastanza diffuso quello che Stanley Cohen nel suo saggio ‘Stati di negazione’ definisce diniego interpretativo o implicito: si attribuisce al fenomeno solo una parte del suo significato, escludendo tutto quello che implica responsabilità e, di conseguenza, dovrebbe muovere all’azione.
È una sorta di sub-negazionismo, o negazionismo di secondo livello, spesso agito da governi, autorità o portatori d’interesse (pensiamo al settore dei combustibili fossili) in modo pubblico ed esplicito, con l’obiettivo di orientare a proprio favore il racconto della crisi climatica. Potrebbe tuttavia essere anche un meccanismo semi-inconsapevole con cui individui e comunità provano a difendersi di fronte a un problema che mette in crisi lo status quo e per cui non esistono al momento soluzioni facili, né di sicuro successo.
Come suggerito dal professor Marco Deriu, l’intensità della negazione della crisi climatica è tanto più forte quanto più l’informazione genera angoscia e diventa insopportabile, facendo scattare un blocco dell’attenzione o dinamiche di autoinganno. Per scardinare questo tipo di negazionismo bisogna lavorare sull’ansia personale e collettiva, e non bastano i dati pur accuratissimi che la scienza può offrire. Il negazionista tende infatti a rifiutare o ignorare qualsiasi narrazione che contraddica il suo frame prevalente. (fonte: https://www.b-story.eu/blog/sostenibilita/crisi-climatica-sensazionalismo-negazionismo/
Perché utilizzare un linguaggio che provoca nei destinatari esiti di segno opposto a quello che l’argomento richiederebbe? Quali strategie per un’efficace comunicazione? Il tema della informazione afferente la crisi climatica è emblematico e consente di riflettere più in generale sui tanti argomenti (politica, corruzione, disuguaglianze, criminalità, ecc.) oggetto di quotidiana somministrazione da parte dei media che, piuttosto che generare movimenti di opinione, scivolano nelle derive del qualunquismo o, peggio, del negazionismo, sfruttabili per favorire opportunistiche strumentalizzazioni politiche da parte di ambienti interessati a sovvertire la notizia per creare una dimensione alternativa, piuttosto lontana dalla realtà dei fatti e dalla verità.
La narrazione della crisi climatica, dunque, al pari di narrazioni che riportano situazioni di rischio/pericolo connesse a fenomeni socio/politici richiede un’accurata progettazione perché sia efficace e sortisca gli obiettivi dell’informazione scientifica.
La comunicazione efficace non può prescindere dalla consapevolezza della diversità e dell’unicità degli individui (ciascuno reagisce in maniera differente, in relazione alla proprie esperienze passate e alle proprie conoscenze) per ognuno dei quali costituire quadri di riferimento immediati e credibili. La difficoltà, già notevole, viene poi ad esasperarsi nelle realtà sociali di tipo multietnico, ormai assai frequenti non solo in contesti metropolitani. In questi casi, infatti, ci si imbatte in complicazioni dovute non solo a lingue diverse, ma a diversi canoni assiologici di riferimento, a differenti percezioni del mondo e degli apparati simbolici (le metafore di uso giornalistico, ad esempio) o a diversi modi di concepire il rapporto con il pericolo e con le istituzioni. Il fenomeno, ben noto, alla scienza della comunicazione deraglia nei contesti giornalistici con risultati che, come quello de qua, si rivelano devastanti. Le narrazioni degli ultimi decenni sono ricche di messaggi neutri o rassicuranti che hanno provocato effetti di paura o panico a causa delle distorsioni dovute a percezioni selettive, interpretazioni emotive ed irrazionali e alle amplificazioni che il pletorico sistema mediatico tende automaticamente a generare.
Comunicati di rassicurazione emessi da fonti ufficiali sono stati, viceversa, talvolta considerati inverosimili. Ciò ovviamente trascende i limiti della comunicazione in condizioni di rischio o di emergenza e trova le sue origini in un più basilare problema di alterazione nel rapporto cittadino/istituzioni, nel fatto che esiste un clima di sfiducia e di scetticismo. Resta, comunque, sempre più inquietante la criticità (di natura interpretativa legata alla struttura e al lessico del messaggio) aggravata dal contesto culturale (si pensi alle società sempre più multietniche) su cui va ad innestarsi la comunicazione in emergenza.
In tale ottica, l’informazione “di servizio”, al di là della sua adeguatezza tecnica, ha elevate possibilità di successo solo se si innesta su un tessuto culturale che può essere costruito solamente con accorte e specifiche politiche di sensibilizzazione di lungo periodo. Diversamente, continueremo a registrare sempre più vasti fenomeni di entropia comunicativa (il periodo da pandemia da Covid-19) che tendono ad alterare la verità dei fatti amplificando incertezze, timori stati emotivi e comportamenti.