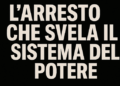C’è un’immagine che tra qualche giorno farà il giro del mondo: decine di barche che tagliano il Mediterraneo, bandiere spiegate, occhi stanchi e determinati. Non partono per un viaggio di piacere. Partono per Gaza.
Il 31 agosto prenderà il via la Global Sumud Flotilla, un’azione collettiva senza precedenti che porterà in mare attivisti, medici, giornalisti, avvocati, artisti, uomini e donne comuni provenienti da ogni angolo del mondo. Gente diversa, ma unita da un’idea semplice e radicale: non restare fermi davanti a ciò che accade.
“Sumud”, in arabo, significa resilienza. Non la resilienza da slogan motivazionale, ma quella che nasce quando non hai alternative, quando resistere diventa l’unico modo per sopravvivere. Ed è questo, forse, il senso più profondo di questa flottiglia: rompere l’assedio imposto da anni su Gaza e provare a far arrivare cibo, medicine, beni essenziali. Ma non solo: arrivare lì è soprattutto un gesto simbolico, un grido che dice al mondo che non possiamo far finta di niente.
Chi parte, lo sa bene: probabilmente non arriverà mai a destinazione. Israele ha già dichiarato che le navi saranno intercettate. È successo in passato e potrebbe succedere di nuovo. Gli attivisti rischiano di essere fermati, arrestati, espulsi. Eppure partono lo stesso. Perché?
Perché, nel silenzio assordante delle diplomazie, c’è chi sceglie di alzare la voce. Di dire che non basta più contare i morti, indignarsi per qualche ora sui social, e poi passare oltre. Gaza è lì, sotto assedio da anni, ridotta alla fame, senza acqua potabile, senza cure mediche, senza via di fuga. Possiamo davvero accettare che il mare diventi un muro?
La Global Sumud Flotilla nasce da questa domanda. È una sfida alla nostra indifferenza. Non è un’azione armata, non è un atto di guerra: è un gesto civile. È la società che, quando le istituzioni si girano dall’altra parte, decide di non farlo.
Certo, ci sono critiche. C’è chi dice che sia un’azione inutile, che le barche non cambieranno la storia. Altri temono un’escalation, uno scontro diretto con la marina israeliana, come già accaduto in passato.
Ma ecco la verità: il punto non è solo consegnare gli aiuti, il punto è rompere il silenzio. Far sì che il mondo guardi di nuovo Gaza, che ne pronunci il nome, che si ricordi che lì vivono persone. Perché un popolo isolato muore due volte: prima per la fame, poi per l’oblio.
E allora sì, anche solo provarci ha senso. Anche solo costringere l’opinione pubblica mondiale a guardare oltre le proprie paure e i propri confini
E lasciatemi fare una domanda: quando è stata l’ultima volta che abbiamo visto qualcuno rischiare davvero per difendere un principio?
La verità è che la forza della flotilla non sta nell’obiettivo materiale — consegnare aiuti — ma nel suo valore simbolico. È un atto che pesa. Pesa perché ci obbliga a chiederci da che parte stare. Non ci sono più alibi, non ci sono più scuse.
A bordo delle navi ci saranno volti noti come Greta Thunberg, Susan Sarandon, Zerocalcare e decine di altri attivisti, ma la forza di questa iniziativa sta soprattutto nei nomi che non conosciamo. Nei pescatori che hanno offerto le loro barche, nei medici che hanno lasciato gli ospedali per salire a bordo, nei ragazzi e nelle ragazze che hanno deciso che non si può rimanere spettatori.
È una scelta di coscienza, prima ancora che di coraggio. Non servono fucili per fare la storia: basta un’azione collettiva che spinga le persone a guardare, a chiedersi da che parte stare.
Non tutti possiamo essere su quelle barche. Ma possiamo fare in modo che non affondino nel silenzio. Possiamo parlarne, informare, condividere. Possiamo pretendere che i nostri governi prendano posizione, che smettano di trattare Gaza come un “problema lontano” e la riconoscano per quello che è: una ferita aperta nel cuore del Mediterraneo.
Sostenere la Global Sumud Flotilla significa stare dalla parte della vita. Significa dire che nessun bambino dovrebbe crescere sotto assedio. Significa credere che la dignità umana viene prima di ogni interesse geopolitico.
Forse la flottiglia non riuscirà ad arrivare. Forse sarà fermata, come tante volte prima. Ma anche se nessuna delle navi dovesse mai attraccare, questa iniziativa avrà già raggiunto il suo scopo: ricordarci che la solidarietà è un atto politico.
E che, davanti all’ingiustizia, scegliere il silenzio equivale a schierarsi dalla parte sbagliata.
Il Mediterraneo, che troppo spesso vediamo come confine, stavolta diventa un ponte. Unisce popoli, voci, storie. È un mare che si ribella, che diventa strumento di resistenza.
Il 31 agosto non sarà solo una data. Sarà un bivio morale. Guardare o distogliere lo sguardo. Restare fermi o scegliere di muoversi.
E, forse, un giorno potremo dire che da quelle barche è partita non solo una missione, ma un’idea nuova di umanità.
Perché il loro viaggio mette ciascuno di noi davanti a una domanda scomoda: quanto vale, per noi, la dignità umana?
Gaza, il grido di Moni Ovadia: “È genocidio, non esistono attenuanti. I vostri figli vi sputeranno in faccia”
Sono passati due mesi da quando Moni Ovadia, voce scomoda e necessaria, ha infiammato una piazza italiana con il...
Basta con il silenzio: il mondo intero si rechi a Gaza. Vediamo se avete il coraggio di ammazzarci tutti
Basta con il silenzio: il mondo si rechi a Gaza. Vediamo se avete il coraggio di ammazzarci tutti Non...
Gaza, un massacro senza fine: oltre 60.000 vittime palestinesi, metà sono bambini
L’inferno a cielo aperto: Gaza come lager del XXI secolo Da oltre otto mesi, Gaza è diventata il simbolo...