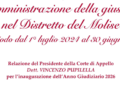Nel cuore dell’inverno politico europeo, mentre il World Economic Forum apre i battenti tra le montagne di Davos, Donald Trump tenta un colpo diplomatico ad alto impatto simbolico: la creazione di un nuovo organismo internazionale, il Board of Peace pensato, nelle intenzioni americane, come una sede alternativa per decidere sulle grandi crisi del pianeta, a partire dal conflitto in Medio Oriente.
L’Italia, però, si prepara a dire no. Un rifiuto netto, che Giorgia Meloni sta maturando lontano dai riflettori, e che non nasce da un gesto di rottura verso l’alleato statunitense ma da una valutazione più profonda, che intreccia Costituzione, diritto internazionale, equilibrio geopolitico e responsabilità finanziaria.
Non è uno scontro personale. È una linea politica.
Il primo ostacolo è scritto nero su bianco nella Carta costituzionale. L’articolo 11 consente all’Italia di partecipare a organismi sovranazionali solo in condizioni di parità con gli altri Stati e solo se tali organismi sono finalizzati a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni.
Il Board of Peace, così come concepito, non risponde a questo principio. La struttura appare fortemente sbilanciata, con una leadership concentrata, poteri decisionali accentrati ed un ruolo dominante degli Stati Uniti. Non un’organizzazione multilaterale nel senso classico, ma un contenitore politico costruito attorno ad una guida forte e a regole fissate dall’alto.
In queste condizioni, l’adesione italiana non sarebbe una semplice scelta di politica estera, ma un passaggio potenzialmente incompatibile con lo spirito e la lettera della Costituzione, soprattutto in assenza di un chiaro percorso di ratifica parlamentare e di garanzie di parità sostanziale tra i membri.
C’è poi un problema più ampio, che riguarda la legittimità internazionale. Il diritto internazionale non nasce da annunci, né da iniziative unilaterali, ma da trattati, negoziati, procedure condivise. Il Board of Peace, almeno nella sua formulazione attuale, non rientra in questo schema.
Il rischio è evidente: creare una struttura che si sovrapponga alle istituzioni esistenti, a partire dalle Nazioni Unite, indebolendo ulteriormente un sistema multilaterale già fragile. Una pace gestita fuori dai canali riconosciuti rischia di essere politica senza diritto, decisione senza garanzia, influenza senza responsabilità.
È anche per questo che Roma guarda con cautela all’operazione: aderire significherebbe legittimare una governance globale fondata più sul peso politico che sulle regole condivise.
A rendere il quadro ancora più delicato c’è la questione economica. L’ipotesi di un contributo miliardario per entrare stabilmente nel Board non è solo una voce di spesa: è un messaggio politico. La pace diventa una membership selettiva, accessibile solo a chi può permettersi di pagare.
In una fase storica segnata da vincoli di bilancio, tensioni sociali e conti pubblici sotto osservazione, investire risorse enormi in un organismo dal mandato incerto espone il governo ad una doppia critica: politica e fiscale. Non è solo una questione di costi, ma di priorità e credibilità.
Il no italiano va letto anche dentro un contesto geopolitico più ampio. L’Italia è parte dell’Unione Europea e della NATO, ed ogni scelta di politica estera ha riflessi sugli equilibri continentali. Aderire ad un forum guidato da Washington, in una fase di forti tensioni internazionali, rischierebbe di isolare Roma rispetto ai partner europei e di incrinare posizioni comuni su dossier cruciali: sicurezza, energia, Medio Oriente.
In questo senso, la scelta di Meloni assume anche il significato di una difesa dell’autonomia europea: non una rottura con gli Stati Uniti, ma il rifiuto di un allineamento automatico.
L’Italia non si sfila dal tavolo internazionale, ma rifiuta di sedersi a un tavolo dove le regole non sono condivise.
Trump arriva a Davos con una visione fortemente personalistica della leadership globale. Un’idea di pace rapida, decisionista, accentrata. Ma questa visione si scontra con un limite che nemmeno le grandi potenze possono ignorare, le costituzioni nazionali e il diritto internazionale esistono proprio per frenare le scorciatoie del potere.
Meloni, pur mantenendo un rapporto pragmatico con Trump, sembra voler fissare un confine chiaro, la pace non può essere costruita aggirando le regole, né trasformata in un progetto politico a geometria variabile.
Dire no al Board of Peace non significa automaticamente difendere la pace, né tantomeno incarnare una superiore moralità istituzionale. Significa, più semplicemente, scegliere un equilibrio diverso, più conveniente in questo momento storico. La decisione di Giorgia Meloni va letta anche dentro le dinamiche interne del governo, nei rapporti con l’Europa, nei vincoli di bilancio e nella necessità di non esporsi su un terreno, quello della politica estera, che potrebbe produrre più costi che benefici.
Il richiamo alla Costituzione e al multilateralismo resta formalmente fondato, ma non esaurisce il quadro. Dietro il rifiuto c’è anche la consapevolezza che aderire a un organismo opaco, costoso e politicamente sbilanciato avrebbe potuto creare fratture interne, tensioni con i partner europei e difficoltà difficilmente gestibili sul piano politico e finanziario. In altre parole, non tutto il no è principio: una parte è prudenza, una parte è calcolo, una parte è realpolitik.
In un contesto internazionale sempre più frammentato, dove la diplomazia è spesso una partita di posizionamento più che di valori, l’Italia sceglie di non esporsi. Non di guidare, non di sfidare, ma di non compromettersi. È una scelta legittima ma che va letta per quello che è, non un atto salvifico, bensì una mossa dentro un gioco complesso, dove anche la pace diventa terreno di interessi contrapposti.
Perché, oggi più che mai, il rischio non è solo che la parola “pace” venga svuotata di senso, ma che venga usata, da tutti, come strumento politico, piegata alle convenienze del momento. E in questo scenario, anche i no, come i sì, non sono mai completamente innocenti.