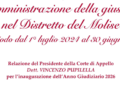C’è una parola che in Italia suona sempre provvisoria: indagata. Non è una sentenza, certo. Non è una condanna. È una fase. Ma quando quella fase diventa ricorrente, quando si ripete come un ritornello stonato – prima Ki Group, ora Bioera – allora la questione smette di essere solo giudiziaria e diventa inevitabilmente politica. E morale.
Daniela Santanchè è nuovamente indagata per bancarotta, questa volta in relazione al fallimento di Bioera, dopo quello di Ki Group. Due società, due crac, due ombre che si allungano su una figura che nel frattempo siede al governo del Paese. Non parliamo di un’imprenditrice qualsiasi, ma di una ministra della Repubblica. E qui sta il nodo. Non è il processo – che seguirà il suo corso – ma il cortocircuito istituzionale che si crea quando il potere politico convive con un passato (e un presente) così fragile sul piano della gestione aziendale.
Ora, se sia colpevole o meno, spetta ai tribunali. La domanda è un’altra: tutto ciò è opportuno? È compatibile? È rispettoso delle istituzioni e dei cittadini?
C’è un punto che spesso viene dimenticato nel dibattito pubblico: la politica non è solo legalità, è anche credibilità. Non basta non essere condannati. Serve essere inattaccabili sul piano dell’etica pubblica, soprattutto quando si rappresenta lo Stato. E qui la sensazione, al di là delle tifoserie, è che stiamo normalizzando qualcosa che normale non è.
Il fallimento di un’azienda può accadere. Il mercato è spietato. Ma quando i fallimenti si sommano, quando le indagini per bancarotta si ripresentano come un déjà-vu, la questione smette di essere una sfortunata coincidenza. Diventa un pattern. E un pattern, in politica, pesa.
Viviamo in un Paese in cui piccoli imprenditori chiudono per un debito non pagato, in cui artigiani perdono tutto per una cartella esattoriale, in cui chi fallisce difficilmente ha una seconda possibilità. Eppure esiste una categoria che sembra immune alla caduta: quella dei politici. Non importa quante inchieste, quanti sospetti, quante ombre. Restano lì. Anzi, talvolta rilanciano. Come se il potere fosse un salvagente permanente.
Non si tratta di giustizialismo. Non si tratta di invocare dimissioni automatiche a ogni avviso di garanzia. Si tratta di una questione più sottile e più profonda: il rapporto tra chi governa e la fiducia dei governati.
Che messaggio arriva ai cittadini? Che la responsabilità vale per tutti, tranne per chi decide per tutti?
C’è un dato politico che non possiamo ignorare: ogni volta che un esponente di governo viene coinvolto in un’inchiesta, la reazione è spesso la stessa. Si parla di accanimento, di complotti, di giustizia a orologeria. Si sposta il piano dal merito dei fatti alla narrazione dello scontro tra poteri. È una strategia efficace: trasforma un problema di gestione aziendale in un caso ideologico. Ma intanto il punto centrale si perde.
E il punto è questo: chi rappresenta lo Stato dovrebbe evitare anche solo l’ombra del conflitto tra interesse pubblico e vicende personali.
Se chiediamo ai cittadini di pagare le tasse, di rispettare le regole, di essere irreprensibili nel loro piccolo, allora dobbiamo pretendere che chi governa sia irreprensibile nel grande.
Il rischio, altrimenti, è quello di alimentare una sfiducia sistemica. Non solo verso una persona, ma verso l’intero sistema politico. E la sfiducia, quando diventa strutturale, è corrosiva: porta all’astensione, al cinismo, all’idea che “sono tutti uguali”. Ed è in quel terreno che la democrazia si indebolisce davvero.
C’è poi un altro aspetto, più sottile ma non meno importante: la dignità della funzione pubblica. Essere ministro non è un diritto acquisito. È un incarico fiduciario. Temporaneo. Revocabile. E soprattutto simbolico. Ogni ministro incarna, nel bene e nel male, un pezzo dello Stato.
Ma allora quanto può reggere un incarico istituzionale di fronte a un susseguirsi di inchieste per bancarotta? Quanto può essere efficace un ministro che, anziché parlare di politiche pubbliche, deve costantemente difendersi sul piano giudiziario?
Forse il problema non è solo individuale. Forse è sistemico. Forse abbiamo costruito una politica che non contempla la parola “passo indietro”. Una politica in cui dimettersi è visto come un’ammissione di colpa, anziché come un gesto di tutela delle istituzioni.
Eppure, in altre democrazie, accade. Si lascia l’incarico per molto meno. Non perché si sia colpevoli, ma perché si riconosce che l’ombra del dubbio può danneggiare la credibilità dell’istituzione.
Da noi, invece, si resiste. Si resta. Si combatte. Si trasforma ogni critica in un attacco politico. È una scelta legittima, certo. Ma è anche una scelta che contribuisce a spostare sempre più in basso l’asticella dell’etica pubblica.
Non è una questione personale contro Santanchè. È una questione che riguarda il modello di classe dirigente che stiamo accettando: una classe dirigente che sembra sopravvivere a tutto, fallimenti, inchieste, polemiche. Come se la politica fosse una zona franca rispetto alla responsabilità che impone agli altri.
La democrazia non si misura solo nelle urne. Si misura nella qualità delle persone che la incarnano. E nella capacità di queste persone di capire quando è il momento di fare un passo indietro per rispetto del ruolo che ricoprono.
Finché non torneremo a pretendere questo, continueremo a vivere in un Paese in cui le aziende falliscono, ma le carriere politiche no. E in cui la parola responsabilità resta sempre buona per gli altri.
Forse non è un problema di legge. Forse è un problema di cultura politica. E la cultura, si sa, non cambia con una sentenza. Cambia con le scelte.
Immagine AI