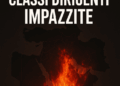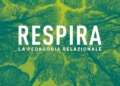Nel marzo del 1944, Roma era una città in ostaggio. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e la fuga del re, la capitale era passata sotto controllo dell’esercito tedesco. I nazisti non solo occupavano militarmente la città, ma collaboravano strettamente con la Repubblica Sociale Italiana nel dare la caccia a ebrei, antifascisti, partigiani e oppositori politici. La popolazione romana viveva nella paura, nella fame e nella repressione.
In questo scenario cupo, l’azione dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) – piccoli nuclei armati comunisti legati al Partito Comunista Italiano – rappresentava una sfida diretta e letale al dominio tedesco.
L’attentato: una bomba in via Rasella
Il 23 marzo 1944, alle ore 15.52 circa, una colonna di 156 soldati tedeschi del Battaglione Bozen – altoatesini arruolati nella polizia ausiliaria nazista – marciava in via Rasella, nel centro di Roma, come facevano ogni giorno.
Quel giorno però ad attenderli c’era un commando dei GAP romani, guidato da Carla Capponi, Rosario Bentivegna, Francesco Cretara, Marisa Musu e altri. L’attacco era stato preparato con precisione: un carretto della nettezza urbana, riempito con circa 12 kg di tritolo e ferro, fu fatto esplodere al passaggio della colonna.
33 militari tedeschi morirono sul colpo o nei giorni successivi, mentre molti altri rimasero feriti. L’esplosione investì anche alcuni civili italiani, causando 2 morti e diversi feriti.
La risposta tedesca fu immediata e brutale. Hitler stesso ordinò una rappresaglia esemplare. Il generale Herbert Kappler, capo delle SS a Roma, organizzò il massacro: per ogni tedesco ucciso, sarebbero stati fucilati 10 italiani. Il bilancio finale fu ancora più tragico: 335 civili e prigionieri politici italiani furono uccisi alle Fosse Ardeatine, una cava nei pressi della città, il giorno successivo, 24 marzo 1944.
Tra le vittime: ebrei, antifascisti, operai, intellettuali, preti, ragazzini. Molti erano detenuti già da tempo nelle carceri di Regina Coeli o via Tasso. Nessuno fu risparmiato.
Nel dopoguerra, l’attentato di via Rasella è stato al centro di un aspro dibattito: fu un atto eroico di resistenza o un gesto irresponsabile che provocò un massacro?
I partigiani difesero con forza la legittimità dell’azione, sottolineando che il bersaglio era un obiettivo militare in piena regola, in un contesto di guerra e occupazione. Non ci fu nessuna “provocazione gratuita”, ma un attacco strategico a una forza armata nemica.
Tuttavia, la destra postfascista hanno per anni sollevato dubbi sulla moralità dell’attentato, accusando i GAP di aver agito senza curarsi delle conseguenze sulla popolazione civile.
Nel 1999, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che l’attentato era un atto legittimo di guerra, condotto contro una forza d’occupazione armata, e dunque non perseguibile penalmente.
L’Italia non ha mai veramente chiuso i conti con la propria storia divisa tra fascismo, resistenza e ambiguità postbelliche. Via Rasella è ancora oggi uno specchio: ci mostra chi siamo, cosa vogliamo ricordare, e cosa invece preferiremmo dimenticare.