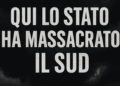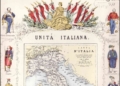C’è una data che nella memoria ufficiale dello Stato italiano è stata sepolta sotto un colpevole silenzio: 6 agosto 1863. Quel giorno, alle porte di Napoli, nell’area industriale di Pietrarsa, quattro operai vennero uccisi e venti rimasero gravemente feriti dal fuoco dei bersaglieri.
Colpevoli di cosa?
Di aver chiesto il rispetto di diritti elementari: una paga dignitosa, orari di lavoro più umani, il pagamento degli stipendi arretrati.
Pietrarsa, orgoglio del Sud
Per capire la portata di quel massacro, bisogna ricordare cos’era Pietrarsa prima dell’Unità d’Italia.
Fondato nel 1840 da Ferdinando II di Borbone, il Reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e per Locomotive di Pietrarsa era il fiore all’occhiello dell’industria meridionale: officine moderne, macchinari all’avanguardia, una Scuola d’Arte per la formazione di operai specializzati e macchinisti.
Qui si costruivano e riparavano locomotive, si producevano pezzi per la rete ferroviaria, si lavorava con tecnologie che suscitavano l’ammirazione di tutto il continente. Lo zar Nicola I di Russia visitò lo stabilimento per prenderlo a modello.
All’apice, nel 1853, Pietrarsa contava quasi 1.000 lavoratori, tra cui 40 detenuti reinseriti nella società: un esempio di fabbrica sociale, oltre che produttiva.
Con la nascita del Regno d’Italia, il destino di Pietrarsa cambiò radicalmente. La politica industriale del nuovo Stato fu segnata da una scelta precisa: privilegiare l’industria settentrionale, in particolare l’Ansaldo di Genova, a scapito dei poli produttivi del Sud.
Una relazione dell’ingegnere Sebastiano Grandis descrisse Pietrarsa come “eccedente nei costi e nel numero di operai” e ne propose addirittura la demolizione. La fabbrica non venne abbattuta, ma peggio: fu svenduta in affitto per appena 45.000 lire annue all’imprenditore Jacopo Bozza.
La conseguenza fu immediata: licenziamenti, aumento delle ore di lavoro, tagli agli stipendi e, in molti casi, mancato pagamento delle paghe.
Le tensioni crebbero fino alla primavera del 1863. Dopo una serie di scioperi e promesse mancate, il 23 giugno Bozza propose il reintegro di alcuni operai licenziati, ma dimezzando il salario di tutti.
Il 6 agosto, quando i 458 operai rimasti non ricevettero lo stipendio, decisero un nuovo sciopero. Alle 14:00 il capo contabile Zimmermann chiamò la polizia di Portici: sei agenti per “contenere” i manifestanti.
Pochi minuti dopo arrivarono i bersaglieri al comando di Nicola Amore (futuro sindaco di Napoli). Gli operai aprirono i cancelli per trattare. La risposta fu una carica alla baionetta e spari alla schiena di chi tentava di fuggire.
Quattro morti:
-
Luigi Fabbricini
-
Aniello Marino
-
Domenico Del Grosso
-
Aniello Olivieri
Venti feriti gravi, decine di contusi. Alcuni morirono in ospedale, altri portarono per sempre sul corpo le cicatrici di quella giornata.
Nella relazione al prefetto, Nicola Amore parlò di “fatali e irresistibili circostanze”. Le responsabilità furono scaricate su “provocatori borbonici”. Nessuna inchiesta, nessuna condanna.
Lo Stato italiano archiviò il caso. Le famiglie degli operai dovettero contare sulla solidarietà della Società Operaia Napoletana, che organizzò una raccolta fondi.
Per oltre un secolo, la strage di Pietrarsa fu assente dai libri di storia. Solo negli ultimi decenni, grazie a storici locali e all’impegno di cittadini, qualcosa è cambiato:
-
San Giorgio a Cremano ha dedicato una via ai “Martiri di Pietrarsa”.
-
San Giovanni a Teduccio ha intitolato una piazza alla loro memoria.
-
Nel 2021 è stata inaugurata una lapide in ricordo delle vittime.
Eppure, la memoria nazionale continua a ignorare quell’eccidio.
Ricordare Pietrarsa significa ammettere che l’Unità d’Italia fu anche un’operazione di smantellamento industriale del Sud, di sangue versato in nome di un disegno economico che penalizzava intere comunità.
Pietrarsa non è solo un episodio lontano. È un monito: quando la politica mette il profitto sopra la dignità del lavoro, quando lo Stato sceglie la repressione invece del dialogo, il prezzo lo pagano sempre i più deboli.
A 162 anni da quella giornata, il Museo Nazionale Ferroviario custodisce i binari, le locomotive e la memoria materiale di un’epoca. Ma il sangue degli operai resta, troppo spesso, memoria scomoda.
Forse l’Italia dimentica perché ha vergogna.
O forse, molto più crudelmente, dimentica perché non sa avere vergogna.
Auletta 1861: la strage che l’Italia unita ha voluto dimenticare