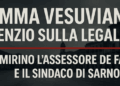L’annuncio è arrivato come un pugno nello stomaco: Benjamin Netanyahu ha dichiarato l’intenzione di procedere con un’invasione totale della Striscia di Gaza. Non è la prima volta che Israele intensifica la sua offensiva, ma oggi, nell’agosto del 2025, ci troviamo di fronte a una decisione che sembra sancire definitivamente la rinuncia a ogni forma di mediazione, a ogni illusione diplomatica, a ogni possibilità di tregua duratura.
Secondo un’inchiesta pubblicata dal New York Times, Israele avrebbe recentemente avuto la possibilità concreta di raggiungere un accordo con Hamas: la liberazione degli ostaggi in cambio di un ritiro graduale e negoziato. Eppure, il governo israeliano si è ritirato all’ultimo momento dai colloqui, preferendo la linea della forza alla diplomazia, il dominio al compromesso. Perché?
La domanda brucia più della sabbia rovente di Gaza: perché questa guerra non finisce mai? La risposta è scomoda, ma necessaria: perché questa non è solo una guerra contro Hamas. È qualcosa di più profondo, più sistemico, più antico. È una guerra per il controllo, per il potere, per la supremazia. È l’eco modernissima di un colonialismo che non ha mai dismesso l’uniforme, ma che oggi si veste di retorica della sicurezza, di autodifesa, di necessità militare.
Che dire, poi, di una coincidenza che sa di beffa storica? Mentre Netanyahu programma la distruzione totale di Gaza, diversi Paesi — dalla Francia alla Germania, dall’Irlanda alla Spagna — hanno annunciato il loro riconoscimento formale dello Stato di Palestina. Una scelta simbolica e politica di enorme portata, che sembra dire: «Esiste un popolo, esiste un diritto». Eppure, proprio quegli stessi Stati riconoscono uno “Stato” che, nei fatti, viene spinto all’annientamento. Non troviamo tutto ciò profondamente paradossale? Viene da chiedersi se non sia invece il segnale di un mondo spaccato a metà tra chi proclama i diritti e chi continua a praticare la violenza come strumento di dominio.
Ci sono oltre 2 milioni di civili intrappolati nella Striscia di Gaza. Molti di loro sono bambini che non hanno mai conosciuto altro che droni, macerie e sirene. Vivono sotto embargo, sotto assedio, senza accesso stabile a cure, acqua, elettricità. Ma questo, nel linguaggio spietato della politica, si chiama “effetto collaterale”. Si può distruggere un ospedale se si sospetta la presenza di un combattente. Si può colpire un condominio se si ritiene che lì si annidino i “terroristi”. Tutto diventa giustificabile, in nome della sicurezza nazionale.
Eppure, quale sicurezza può nascere sulla morte di migliaia di innocenti? Quale pace può germogliare nel sangue?
Netanyahu, leader ormai logorato da scandali interni e da un crescente isolamento internazionale, sembra voler giocare la carta dell’estremismo per cementare il suo potere. L’invasione totale, più che un’operazione militare, appare come una dichiarazione ideologica: non ci sarà uno Stato palestinese, non ci sarà tregua, non ci sarà concessione. Solo terra bruciata.
Nel frattempo, le diplomazie mondiali balbettano. Le potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti e l’Unione Europea, si dividono tra silenzi imbarazzanti e dichiarazioni contraddittorie. Le manifestazioni popolari in molte capitali chiedono il cessate il fuoco, ma le cancellerie rispondono con frasi vuote. Le Nazioni Unite, come spesso accade, restano ostaggio del veto e dell’impotenza.
La verità è che questa guerra fa comodo a troppi. Alimenta l’industria bellica, consente di distogliere l’attenzione da crisi interne, rafforza il controllo sui territori e sulle risorse. È una guerra che si autoalimenta, dove la pace è un rischio per chi trae potere dal conflitto.
E così, nel 2025, mentre parliamo di intelligenza artificiale e viaggi su Marte, c’è ancora un popolo che vive sotto occupazione, bombardato quotidianamente, raccontato troppo spesso come “problema” e mai come essere umano. Questo è il vero scandalo: il colonialismo non è finito, ha solo cambiato nome.
Allora riflettiamo su ciò che sta accadendo, interroghiamoci sul senso di questa tragedia protratta, non cediamo all’assuefazione. Perché ogni volta che voltiamo lo sguardo, ogni volta che etichettiamo come “inevitabile” ciò che è il risultato di precise scelte politiche e militari, diventiamo complici.
Non possiamo più permetterci il lusso dell’indifferenza.